
Vista da quarant’anni di distanza, l’estate del 1982 non sembra più bella di quanto sentivamo nell’attraversarla davvero, noi ultimi figli di quella crescita demografica che si sarebbe inceppata per sempre. Essere stati proprio in quel tempo sulla linea d’ombra che divide la giovinezza dall’età adulta fu un caso, trasformato dal reale in privilegio.
Era davvero la prima estate degli anni Ottanta. Tutti a dire che il decennio precedente era stato terribile, poi basta; però Mattarella Ustica e Bologna erano dell’80, cosi come dell’81 l’attentato a Wojtyla. Ed è vero che a settembre, pure in quell’estate così colorata, la sventagliata di mitra era toccata al generale Dalla Chiesa, che tuttavia era un protagonista - appunto - degli anni di piombo, finito per sbaglio a Samarcanda, per capriccio di un banale destino a casaccio incontrato dopo avere schivato il suo, più di Schumacher sugli sci oppure di Zanardi in bicicletta che ancora guerreggiano.
Nel giugno che inaugurava l’estate, usciva un disco con nove canzoni che non ce n’era una sbagliata e tre almeno erano non so neppure io dire che cosa: Caterina, San Lorenzo e La leva calcistica della classe ’68. Una d’amore e nostalgia, una di guerra e pace, una sulle illusioni dell’infanzia che perfino parlava di quel calcio che gli anni Settanta dell’ideologia avevano relegato a impronunciabile oppio dei popoli. Le ascoltavamo intuendo fin da subito che sarebbero rimaste.
Il calcio, già. Per alcuni di noi il 6 giugno era stato il ritorno in serie A dopo cinque anni, Sampdoria-Rimini 0-0, il modo più scialbo di celebrare l’anabasi di noialtri allora stranieri in patria, con tutta una storia da scrivere - e che storia. Ma questa è cosa mia e di quelli come me.
Divenne di tutti gli italiani, invece, l’evento sportivo più importante del nostro Novecento, un mese cominciato col campionato di B ancora in corso. Quel Mondiale di Spagna durò soltanto sette partite, ma una era La partita, proprio così si intitola il formidabile libro di Piero Trellini, più di seicento pagine per raccontare quell’ora e mezza al Sarrià di Barcellona, dove c’era lo stadio ora c’è un supermercato, 5 luglio alle cinque e un quarto della sera, da una parte la squadra più forte di sempre e dall’altra l’Italia. Ci saremmo ricordati per sempre dove fossimo e con chi, a vedere l’impossibile. Le quattro gare prima e le due dopo quasi non sono che statistica, Italia-Brasile fu invece il cuore fiammante di quell’estate. E addolora che a ricordarla non ci sia più quel ragazzo che il Vecio continuava a far giocare, malgrado non segnasse e fosse pure reduce da una squalifica. E non c’è più nemmeno un altro illusionista che aveva escogitato la colonna sonora di quell’estate: “La voce del padrone”. Ed era bellissimo perdersi in quell’incantesimo.
Ne uscivano di dischi che sarebbero rimasti. Come Night and Day di Joe Jackson, un allampanato polistrumentista delle Midlands che era partito dal punk per arrivare a comporre sinfonie. Ma questo era il disco di Breaking us in two, il video in una stazione di partenze e arrivi, di inizio e fine perché i treni hanno qualcosa a che vedere con l'inizio e con la fine. E proprio in Inghilterra, sul prato spelacchiato di Wimbledon, un cocciuto tennista mancino dell’Illinois camminava finalmente sull’ombra dello Svedese, non quello di Philip Roth naturalmente. Otto anni dopo la finale troppo facile con l’ormai quarantenne Rosewall, preludio alla lunga eclissi patita con Borg e col suo gioco noioso da imbattibile macchina allenatrice, James Scott “Jimmy” Connors vinse al quinto contro un altro matto come lui, John McEnroe, in una finale violenta e romantica, cattiva ed esilarante. Giocava con quella sua assurda racchetta di acciaio col filo di ferro a tendere le corde, scintillante come un’arma bianca. E aveva sconfitto, almeno quella volta, l’avversario di tutti: il tempo che passa.
E poi, quando già era settembre, ancora in Inghilterra quello scatto in volata, una cosa assurda che non si era vista prima e non si sarebbe vista più. Sembrava che Saronni, come prima di lui Bartali e Anquetil, il Mondiale non lo dovesse vincere mai. Nel ’78 al Nurburgring era nella fuga buona con Knetemann e Hinault e lui era il più veloce, francesi e italiani e olandesi non si muovevano e ad andarli a riprendere erano stati Godefroot e gli altri belgi, non si seppe mai per conto di chi; o forse sì. Tre anni dopo, a Praga, ancora peggio: Baronchelli se n’era andato ma a riprenderlo erano stati gli italiani, così sospettando di Saronni gli aveva reso il favore all’arrivo, sul rettilineo della collina di Strahov accanto a quello che ancor oggi è lo stadio più grande del mondo perché ne contiene altri sette, fingendo di tirargli la volata e sfilandosi sul più bello, lasciandolo al vento e al ritorno di Maertens che alla fin fine l’unico italiano a batterlo allo sprint era e sarebbe stato Gimondi,
Poi venne quel 5 settembre e i tifosi di Saronni, non tutti quindi i tifosi italiani, videro finalmente l’azzurro col numero 96 scattare ai trecento metri e in quello spazio frantumare il tempo, cinque secondi a Lemond e dieci a Kelly, ciao a tutti ed ecco quella maglia arcobaleno, la più bella.
Sono immagini, ricordi, splendori sull’erba che forse dicono poco anche a chi c’era e quindi niente a chi è venuto dopo. Però ad aver fatto diciott’anni in quell’estate capace che dicano quasi tutto. Passò quella stagione e sono passati gli anni, resta qualcosa in chi resta. Era di quarant’anni fa anche la canzone più adatta a rileggere quella folata di giorni: Celeste nostalgia, l’avrebbero subito usata i Vanzina per girare un film che parlava degli anni Sessanta, perché ognuno rimpiange il tempo che ha vissuto e quindi figuriamoci - come ha spiegato Allen in Mezzanotte a Parigi - quello che non ha vissuto. E quel film finiva così: “Sei sempre la più bella”.
 8° C
8° C LIVE
LIVE



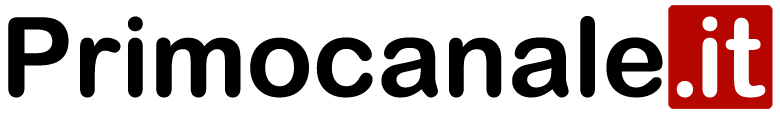
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 29 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 28 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiDa Genova ad Hamas, a Roma: troppe parole in libera uscita
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?