
C'era una volta il Consorzio Autonomo del porto, il CAP. Autonomo, sottolineiamo questo termine. Così si chiamava l'ente creato da legislatori intelligenti e lungimiranti nel 1903.
Lasciamo da parte gli anni antichi, nei quali questo Cap governava le banchine avendo tra i “soci” anche diversi comuni importanti del Nord Italia a sottolineare l'importanza nazionale del ruolo.
Lasciamo da parte le polemiche, che hanno quasi sempre circondato questo Cap, grande soggetto istituzionale e regista dei destini genovesi per la sua indipendenza rispetto al Comune, alla Regione, alla Provincia, alla Camera di Commercio, all' Associazione degli Industriali.
In queste polemiche c'entrava anche lo status dei suoi dirigenti e dipendenti, ben diverso economicamente, ma anche giuridicamente, da quello degli altri dipendenti pubblici locali. Il Cap era “a parte”.
I presidenti, che sono stati quasi sempre figure eminenti dell'economia, della politica, perfino della Marina e della società civile, esperti di marittimo, incoronati a san Giorgio e intoccabili per la loro competenza o per l'autorità che permetteva loro di stare nel cuore della città, ma distinti dagli altri poteri.
E veniamo ai tempi più moderni, magari ai sedici anni delle cavalcate indimenticabili di presidenti del Cap, come Roberto D'Alessandro, Rinaldo Magnani e Giuliano Gallanti.
Agivano in perfetta autonomia, in concorso con il governo nazionale e hanno prodotto, non certo senza sofferenze e contese, la privatizzazione delle banchine, la rottura dei monopoli paralizzanti e la “terminalizzione” del porto, che era sprofondato nell'abisso dell'inizio anni Ottanta, quando a Capodanno non suonavano neppure le sirene perchè non c'era a Genova neppure una nave.
Cosa è successo dopo questo regno positivo di grandi occasioni create non solo all'economia genovese e a quella nazionale? Quando è cambiata la legge, magari anche per grandi motivazioni internazionali di adeguamento a esigenze europee e alla trasformazione mondiale del traffico, il CAP è diventato l'Autorità di Sistema Portuale e, di fatto, ha perso progressivamente l'Autonomia.
Da allora si sono scatenati gli appetiti di Comune e di Regione sul governo dello scalo. Palazzo San Giorgio, che era ciò che la Storia aveva insegnato e prodotto nel suo percorso secolare, è diventato una specie di dependance degli altri poteri, che con l'alibi della regia di governo cittadino e regionale, hanno incominciato a mettere le mani nelle banchine, sui moli con un interesse crescente.
Simbolo di questa tensione anche la eterna contesa del Piano Regolare Portuale con quello cittadino, che dura tutt'ora perchè, appunto, la storia di quella autonomia ha ancora un significato. Addirittura si è cercato di proporre o di spingere modelli che eliminassero del tutto la “differenza” tra il governo del porto, diventata Autorità di sistema, e il sindaco di Genova con una soluzione alla catalana, come a Barcellona, invocando un Doge che finalmente governasse insieme città e banchine.
Invece quell'autonomia, quella differenza di governo con il presidente e il Comitato, organo fondamentale e di totale rappresentanza degli enti e delle categorie interessate al governo portuale, sono stati cancellati e sostituiti da un meccanismo che sembra perfetto per esaltare i poteri esterni al porto e la loro possibilità di influenzare decisioni chiave non solo per Genova.
Il presidente è stato scelto dalla “politica” con un criterio diverso dalle modalità precedenti, che saranno state pure spesso lottizzatorie e influenzate dai partiti politici, ma alla fine creavano una certa selezione.
Alle spalle c'erano le segreterie dei partiti, che allora contavano ed erano capaci di esprimere e pesare esigenze generali, pur nei loro giochi e strategie e di far contare anche valori importanti non solo dell'economia marittima.
Invece ecco che con il metodo nuovo alla presidenza arriva un funzionario con esperienze ministeriali e comunque pubbliche, distaccato dalla città, come mai era avvenuto, senza la richiesta e “comprovata esperienza nel settore marittimo” e ben presto preda del Comune, della Regione, cooptato come il terzo componente del blocco di potere locale, con la ruota di scorta del board del nuovo Comitato, sintetizzato in tre personaggi, fior da fiori scelti e chiaramente titolari di interessi precisi. Come i fatti recenti dimostrano, anche senza fare nomi e cognomi.
Altro che Autonomia: il porto è diventato il cuore di una strategia che nella rapida trasformazione della città, nella sua fase post industriale, è rimasto l'asset principale di sviluppo, mentre intorno c'erano solo infiocchettamenti come il turismo, i servizi, le nuove tecnologie, eccetera eccetera.
Da qui il grumo di potere cresciuto intorno al porto, il ruolo dei terminalisti crescente, trasbordante, il registro della regia portuale sempre più debole, e, quindi, un vero capovolgimento dei pesi e delle misure intorno alle banchine, già di per se stesse sottoposte a una gigantesca trasformazione.
Tutto questo potrebbe sembrare un discorso anti storico, nostalgico, inutile. Ma a me è venuto in mente di fronte alle recenti e scottanti notizie di questi giorni: la grande inchiesta giudiziaria, il cui nocciolo è principalmente il porto, le banchine, le concessioni, i giochi di potere intorno.
E mi è venuto in mente anche di fronte alle 17 pagine di Toti, alla sua accanita difesa, che mostra, oltre a tutto il resto, il ruolo centrale di regia anche del porto, che il presidente sentiva sulle sue spalle, nel suo ruolo. Alla faccia di Signorini e delle suites offerte da Aldo Spinelli.
Forse se quell'autonomia esistesse ancora, magari in una forma diversa da quella scritta nel 1903, non si sarebbe formato quel gorgo che minaccia di inghiottire un pezzo del nostro sviluppo. Accuse e fatti di ipotetiche corruzioni a parte.
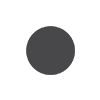 6° C
6° C LIVE
LIVE
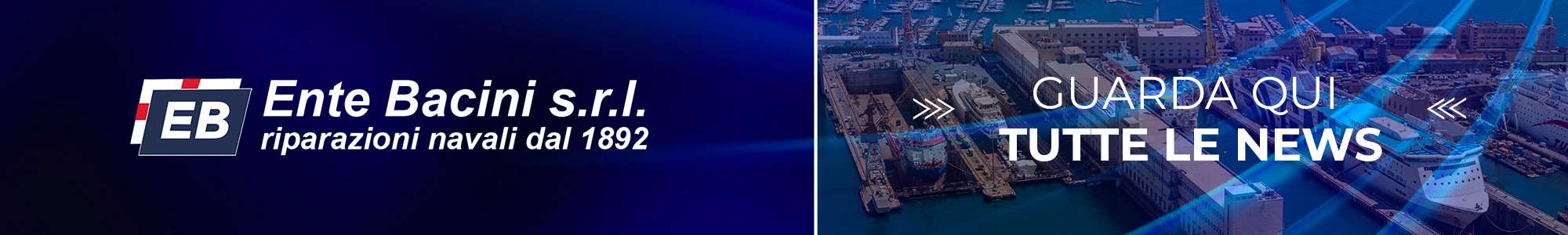

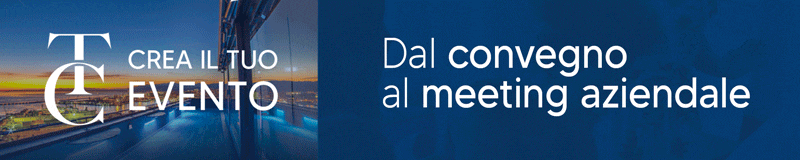
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 11 Gennaio 2026
-
Franco Manzitti
Sabato 10 Gennaio 2026
leggi tutti i commentiLa grande questione di Genova che non riesce a diventare giovane
Portare la fiaccola olimpica che è passata per Genova