Cristian Mungiu, la punta di diamante del ‘nuovo cinema rumeno’, è un regista cui piace prendersi il suo tempo, sia in termini di carriera (sei film in ventun’anni) che nel modo di girare: mette insieme i vari tasselli delle storie che racconta senza fretta, tessendo un arazzo che richiede un po' di tempo per rivelare tutta la complessità e l'arte della sua costruzione. Lo stesso accade anche in ‘Animali selvatici’, ambientato in un piccolo paese della Transilvania. Un’area geografica, ci fa capire, che con la sua natura multilinguistica (si parla rumeno, ma anche ungherese e perfino un po' tedesco) è un perfetto esempio della linea sottile che separa il senso collettivo di appartenenza alla cristallizzazione della paura degli altri, quegli estranei provenienti da un altrove che non si conosce su cui le persone proiettano le proprie angosce.
In questo paese dove è nato torna Matthias dopo aver lasciato il suo lavoro in un macello tedesco in seguito ad un litigio con il caposquadra che lo aveva definito “uno zingaro”. Lì ritrova la madre di suo figlio, un ragazzo che non parla più da quando ha visto in un bosco qualcosa che lo ha traumatizzato e l’ex amante che gestisce una panetteria industriale e insieme alla proprietaria, per raggiungere il numero minimo di dipendenti necessario ad ottenere finanziamenti europei, assume tre lavoratori provenienti dallo Sri Lanka che finiranno per scatenare ansie e preoccupazioni nella popolazione locale fino ad arrivare ad un conclamato e violento razzismo. Uno zelo xenofobo che unirà i cattolici e i luterani della città da sempre in guerra tra loro, i nativi ungheresi e l'etnia Rom intorno a un nuovo e pericoloso nemico: un esercito di tre sole persone.
Con ‘Animali selvatici’ Mungiu ha realizzato un film spaventoso sulla paura collettiva e individuale in una comunità in disintegrazione. Le connessioni economiche e politiche che emergono sono presentate senza pregiudizi così come i cambiamenti delle persone che possono passare dall'affetto e dalla disponibilità alla violenza e alla rabbia in pochi secondi e viceversa. E uno dei paradossi del film – in cui la chiesa funge da metafora dell’irrazionalità collettiva - è l'irrisolvibile illogicità che allo stesso tempo non vuole tollerare i lavoratori stranieri nelle proprie fila mentre la maggioranza della popolazione è in cerca di lavoro all'estero.
E’ la parabola di un mondo in transizione. Mentre i film precedenti Mungiu li aveva costruiti intorno a drammi di singole persone qui mostra una visione più ampia, diagnosticando un'intera città malata di uno spaventoso cancro mentale e dipingendo un ritratto molto preciso del microcosmo che lo abita: il prete, il sindaco, gli impiegati della fabbrica, i leader dei gruppi anti-migranti e via dicendo. Scruta nell’abisso e non offre nessuna risposta né una facile via d’uscita alla capacità umana di odiare senza alcuna razionalizzazione. Ne vien fuori un affresco inquietante che prende forma intorno alla questione chiave del comportamento di una collettività di fronte ai suoi impulsi per la vita e per la morte.
 8° C
8° C LIVE
LIVE





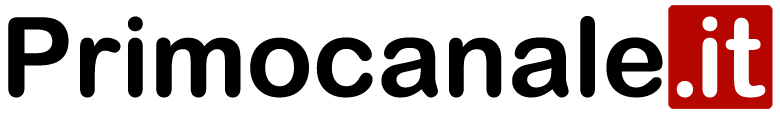
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 29 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 28 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiDa Genova ad Hamas, a Roma: troppe parole in libera uscita
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?