
Stanno arrivando elezioni invisibili. Ne parliamo e scriviamo noi giornalisti, certo, ma a girare in città sembrano interessare più che altro appunto a noi, naturalmente ai candidati e ai sempre più rari militanti di quei pochi partiti rimasti come tali.
I manifesti sui muri ci sono, anche se spesso si confondono con le pubblicità delle agenzie immobiliari e dei centri estetici. I volantini sotto i tergicristalli delle macchine e nella cassetta postale, anche. Sembra però mancare qualcosa, rispetto a quando votare era considerato qualcosa di importante e forse lo era davvero. E non solo i comizi di piazza, vero stigma abbandonato e occasione anche di corrida, sostituiti quasi sempre da eventi ristretti, in locali al chiuso, dove per lo più convengono i sostenitori e quindi i già convinti.
Certo, da qualche tempo - complici regole scoraggianti, volute e attuate da chi ha come sola bussola l’autoperpetuazione della specie protetta, la propria - il corso degli eventi non aiuta a incentivare la partecipazione. Da quattordici anni non troviamo più un presidente del Consiglio che, per essere nominato dal Quirinale e fiduciato dalle Camere, sia prima passato in qualche modo dal voto popolare, se non altro per farsi conoscere: non dico come candidato premier, locuzione impropria perché mai prevista da alcuna legge, ma proprio anche come candidato semplice. L’obiezione formalistica del pieno rispetto dell’architettura costituzionale, che tanto piace a chi parteggia per chi governi in quel preciso momento, anche nell’eclatante e recente scelta di un perfetto sconosciuto individuato proprio perché tale, si espone però a pari controargomentazioni: io sono celibe battezzato e maschio, perciò in teoria eleggibile come Papa, anzi il battesimo nemmeno servirebbe in partenza, perché mi verrebbe impartito dopo elezione e accettazione. Quindi la mia elezione a vescovo di Roma sarebbe sì giuridicamente perfetta, tuttavia non si può negare che rappresenterebbe uno strappo non da poco rispetto a duemila anni circa di prassi costituzionale.
Il sempre più marcato distacco tra esito numerico del voto popolare e formazione di coalizioni e governi nazionali vale a spiegare in parte astensionismo e quindi disaffezione, ma non basta. Non basta, per lo stesso motivo per cui non si spiega perché risentimento e disincanto giovanili di una volta, parlo degli anni dai Sessanta agli Ottanta, non producessero l’attuale fuga dalle urne, anzi si traducessero non solo in grande partecipazione, ma perfino nella scelta di cambiare le cose non votando ma con la lotta armata.
Nessuno qui rimpiange il terrorismo, ci mancherebbe, lo fanno già molti dei suoi nostalgici protagonisti e fiancheggiatori. Ed è uno spettacolo osceno. Però è ben strano che un Paese che stava bene producesse manipoli di tenebrosi sanguinari, mentre un Paese impoverito e quasi disperato come quello di oggi produce al massimo i seguaci di un ecologismo che fa tenerezza per il suo contenuto utopico gravido di rimedi peggiori dei mali. Non c’è una ragione logica, ancor prima che storica e politica, perché quelle squadre di assassini e bombaroli fossero sorte proprio nel tempo di massimo benessere per il Paese dalla fine della guerra, quando la possibilità di espandere a piacere il disavanzo, tacitamente convenuta in via consociativa tra la forza necessaria di maggioranza e quella necessaria di opposizione, consentiva in pratica l’erogazione di un gigantesco reddito di cittadinanza a quasi tutto il Paese, tra industrie private tenute in piedi (con relativi posti di lavoro e stipendi) soltanto dalle sovvenzioni statali e aziende pubbliche dalle piante organiche infinite e senza nemmeno il bisogno di chiudere i bilanci in attivo, fino a un sistema pensionistico prodigo fino alla scelleratezza; insomma un quadro da paese dei balocchi, deteriore rispetto al presente solo dal punto di vista tecnologico. Eppure i “boom” cattivi del terrorismo sono cominciati proprio in sincronia con il “boom” buono della crescita socioeconomica, sia pure drogata da quello che sarebbe diventato il terzo debito pubblico del pianeta.
Forse a spiegare quel che accadeva allora non bastano le sentenze della nostra magistratura, che non è diventata non sempre attendibile e non sempre imparziale solo dopo il concorso vinto dal dottor Palamara e dai suoi sodali. Forse sarebbe il caso magari di cercare, a poterlo fare, negli archivi dei servizi delle potenze che per quarant’anni almeno avevano fatto dell’Italia la rete del loro campo da tennis. Di questi tempi stiamo tanto a parlare di come Paesi stranieri s’intrudano nella nostra vita, reclutando sicofanti e agenti, truccando le elezioni eccetera. Succede solo adesso, vorremmo credere, quando l’Italia conta ormai purtroppo meno di zero?
Comunque sia, la partecipazione politica si direbbe in via di estinzione. A votare ci va un italiano su due, anzi quasi sempre meno. Però se per le legislative questo discorso regge, sulle comunali il tema non sta in piedi. Perché l’elezione diretta ti mette davanti la faccia di quello che voterai o non voterai, e non sono tutti uguali e chiunque vinca fa lo stesso. Certo, ci saranno quelle aree “filogovernative a prescindere” che dopo il voto si schiereranno retrodatate col vincitore. Vecchia storia, specie qui ma non solo. Ma dalla scelta di un sindaco, almeno da quella, e di un presidente di regione dipende qualcosa di molto concreto; inoltre in questi due casi la persona la si può scegliere eccome.
Eppure non funziona lo stesso. Difatti i candidati tendono non tanto a rubar voti nell’altro campo, impresa oltretutto quasi impossibile in un’Italia che, se prendete i dati del 18 aprile 1948 rileggendoli alla luce di scissioni e frammentazioni e apostasie e riverniciature successive per non parlare dei “finti nuovi”, scoprirete che vota sempre e da sempre alla stessa maniera per gli stessi partiti, malgrado plastiche facciali e cambi anagrafici. Si punta al massimo a recuperare i delusi della propria parrocchia.
Di certo a scoraggiare gli elettori è la qualità sempre meno convincente delle proposte loro rivolte. Chiusa l’epoca delle scuole di partito, dell’apprendistato graduale dove per andare in Parlamento si cominciava attaccando manifesti di notte, della selezione motivata, oggi l’impressione difficilmente dissipabile è che molti si candidino per tentare la fortuna, trovare un lavoro, come se fosse un concorso pubblico per un posto ottenibile non studiando e preparandosi ma convincendo più gente possibile a dare il voto. In pochi - dal modo stesso in cui si propongono - danno l’impressione di voler davvero fare qualcosa per il bene comune, e per mia fortuna ne conosco; ma in gran parte ti guardano dal cartoncino come se fossero in attesa di sapere finalmente che cosa rispondersi allo specchio dopo la domanda “Chi sono?”.
Bisogna invece andare a votare, sempre, non fosse altro per togliere alibi a chi, prima o poi, si alzerà a dire: ormai alla gente le elezioni non interessano più, tanto vale abolirle e risparmiamo. Anzi, in Italia è già successo, anche di recente e sul più autorevole quotidiano nazionale a firma di un suo direttore storico. Per dire l’aria che tira. E non stiamo a sentire fino in fondo chi dice una cosa per certi versi vera: la democrazia ha fallito. In parte è così, il suffragio universale andrebbe infatti almeno temperato, ma chi decide come? Siamo daccapo. Certo, il Paese che oggi al mondo funziona meglio di tutti, tra espansione economica e politica e - speriamo di no - militare, è tutt’altro che una democrazia. Ma il voto resta la base di tutto; perché ti accorgi di quanto sia importante poterlo fare solo quando non te lo permettono più.
 9° C
9° C LIVE
LIVE



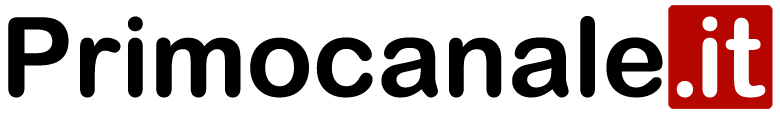
IL COMMENTO
-
Matteo Angeli
Giovedì 25 Dicembre 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 22 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiIl Natale della comunità: l'impegno di Primocanale e gli auguri della redazione
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie