
Forse mai prima d’ora il 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo, ha avuto un valore così simbolicamente attuale come quest’anno, lungi da ogni retorica celebrativa e agiografica.
Ciò perché è innegabile che la democrazia italiana si fonda sul nesso inscindibile tra Resistenza-Repubblica-Costituzione; così come è innegabile che il “sogno europeista” nasca dal pensiero antifascista europeo, dal progetto dei visionari di Ventotene e, negli anni Venti del Novecento, dall’invocazione di Giacomo Matteotti che, prima del suo assassinio, auspicava la costituzione degli Stati Uniti d’Europa per debellare nazionalismi e revanscismi. Due pilastri degli ordinamenti liberal-democratici, nazionale e sovranazionale, costruiti nel dopoguerra, che oggi rischiano di essere erosi e disgregati sotto la spinta di ideologie e movimenti nazional-populisti.
Infatti, con la lotta di Resistenza nasceva una nuova idea di Patria italiana, fondata su diritti di libertà, democrazia e pace, che il fascismo aveva calpestato. Ma questa nuova idea di Patria veniva posta nell’alveo di una più grande Patria europea, come amava definirla Carlo Azeglio Ciampi, fondata sullo stato di diritto e sulla unione dei popoli del vecchio continente, i quali per secoli si erano combattuti e massacrati. Entrambi questi ideali si saldarono con un nuovo diritto internazionale consacrato nella Carta delle Nazioni Unite approvata nel giugno del 1945 a pochi mesi dalla fine del secondo conflitto mondiale.
Non può sfuggirci, dunque, mentre celebriamo la Liberazione dell’Italia e dell’Europa da nazifascismo, che quella democrazia allora riconquistata è oggi messa a repentaglio da aggressioni armate, guerre commerciali, violazione dei diritti della persona e del diritto all’autodeterminazione dei popoli.
La partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova in occasione dell’80° della Liberazione ha, per queste ragioni, un particolare significato poiché è al contempo un omaggio alla città Medaglia d’Oro al V.M. nella quale venne firmato l’atto di resa di truppe regolari germaniche nelle mani dei componenti il CLN-Liguria: un “unicum” in tutta la guerra europea, come scrisse P.E. Taviani. Ma sarà anche una occasione per richiamare le radici della democrazia nella sua dimensione sovranazionale.
Del resto, la firma che pose fine a Genova alla Seconda guerra mondiale, rappresentò, simbolicamente, anche un primo passo verso la pace e la riconciliazione dei popoli.
Un atto e un esito non scontato, come la tragedia di Varsavia e di altre città europee ammoniva, che giungeva dopo venti lunghi mesi di lotta partigiana, di città e di montagna, che aveva visto protagonisti uomini e donne di ceti sociali, sensibilità culturali e orientamenti politici assai diversi, ma che seppero unirsi nella volontà di riscatto della dignità propria e del proprio paese.
Per tutte queste ragioni ognuno di noi è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità oggi e non è banale e rituale riaffermare gli ideali che animarono la Resistenza, che i Costituenti inscrissero nei principi fondanti della Repubblica e i Padri fondatori nel progetto dell’Unione europea.
*Giacomo Ronzitti è presidente dell'Ilsrec-Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea "Raimondo Ricci - Fondazione Ets"
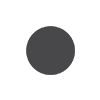 8° C
8° C LIVE
LIVE


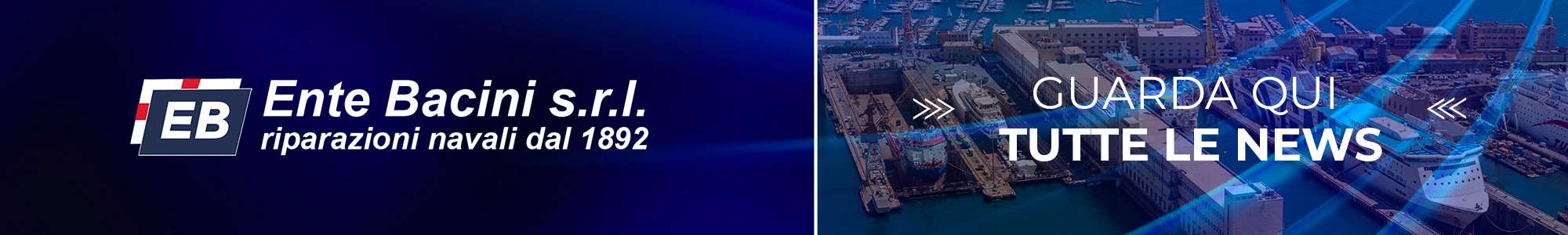

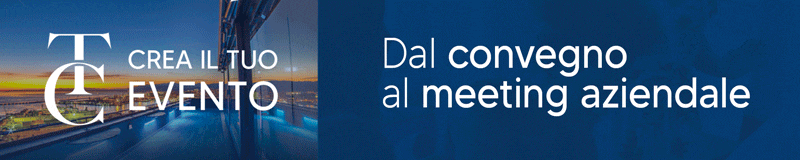
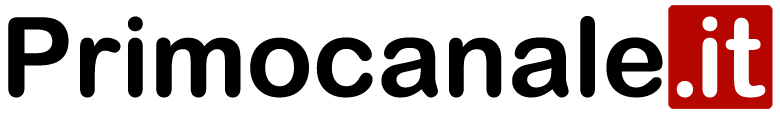
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 29 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 28 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiDa Genova ad Hamas, a Roma: troppe parole in libera uscita
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?