
In quell'otto giugno del 1976 mi stavo recando all'Università per l'ennesimo esame alla facoltà di Giurisprudenza. Stavo in piazza Principe, appena sceso dal treno che da Imperia mi aveva portato a Genova, quando l'aria venne squarciata dal forte sibilo delle sirene. Sembrava una sola, ma in realtà erano molte: della Croce Rossa, dei carabinieri, della polizia. Un trambusto enorme.
Continuai il mio cammino verso "Legge", come si diceva allora, e arrivato nei pressi di Salita Santa Brigida riuscii appena a percepire che qualcosa di molto grave era accaduto. Ma il pensiero dell'esame era il mio chiodo fisso. Così, sebbene avessi già iniziato la mia esperienza giornalistica presso la redazione imperiese del Secolo XIX, proseguii per la mia strada: non c'era nulla che potessi fare, anche se già orgogliosamente mi fregiavo del titolo di giornalista (l'esame professionale lo avrei dato cinque anni più tardi).
Già all'Università seppi che tutte quelle sirene nascevano dall'attentato a Francesco Coco, trucidato insieme alla sua scorta dalle Brigate Rosse solo perché aveva rifiutato di firmare la scarcerazione della banda XII Ottobre in cambio della liberazione del collega Mario Sossi. Era nato a Imperia, Sossi, anche se il suo cognome in città era conosciutissimo soprattutto perché significava un bar-pasticceria capace di ogni prelibatezza.
Leggendo gli articoli di Mario Paternostro e Franco Manzitti mi sono tornati in mente quei giorni, quelle ore. Certo, noi a Imperia non stavamo nell'epicentro della crisi terroristica, come a Genova. Però li abbiamo vissuti con angoscia e apprensione, quei momenti. E pure con imbarazzo. I brigatisti imperiesi in realtà non arrivarono a essere assassini, ma fiancheggiatori ce ne erano eccome. E li conoscevamo praticamente tutti. Non perché avessimo chissà quali doti investigative, bensì perché loro per primi si facevano riconoscere. Nell'ufficialità delle cose, però, stavano sempre attenti a non oltrepassare il limite: insomma, se qualche reato lo commettevano, quello avveniva di nascosto, al riparo da occhi e orecchie indiscrete.
Questa cosa era nota e fu anche per questa ragione che la questura decise di darci un occhio attento durante il giorno e anche nelle ore notturne. Arrivammo al presidio vero e proprio della redazione quando venne rapito il presidente della Dc, Aldo Moro. Un funzionario della prefettura venne in redazione e ci avvertì che da quel momento di fatto stavamo sotto scorta. "Non ci aspettiamo che capiti nulla - fu la spiegazione - ma la prudenza non è mai troppa".
In effetti non capitò nulla di paragonabile a ciò che avveniva a Genova e nel resto d'Italia. Tuttavia... Ricordo, così, quando mi capitò di dover testimoniare che uno dei giovani di ultrasinistra, erano quasi tutti intorno ai 20-25 anni, stava in redazione al Decimonono nel momento in cui, a Padova, le forze dell'ordine misero le mani su uno esattamente con quel nome e quel cognome (non cito le generalità perché l'interessato non ha mai subito condanne). Risultava da un documento smarrito "accidentalmente", almeno secondo la denuncia avvenuta regolarmente ai carabinieri di Imperia.
Apparve a tutti evidente che quella persona, nota per le sue simpatie verso le Br, in realtà aveva fornito agli amici padovani la sua carta di identità ed era venuto in redazione per darsi un alibi: ma nessuno poteva dimostrarlo. E dunque ci toccò l'ingrato compito di testimoniare una verità vera solo all'apparenza. Però sì, stava lì da noi. Ma sono sincero: per me, oltretutto figlio di un carabiniere, fu davvero molta la tentazione di forzarla, quella verità.
È proprio ricordando questo episodio, pur incommensurabilmente diverso e più facile, che in qualche modo ho tuttavia compreso che cosa dovette passare per la mente di Guido Rossa. Il quale, invece, i brigatisti li aveva in fabbrica come compagni di lavoro. Ma una cosa era sapere, un'altra avere la forza e il coraggio di denunciare. Lui seppe farlo, a costo della vita. Non finiremo mai di dirgli grazie.
 6° C
6° C LIVE
LIVE



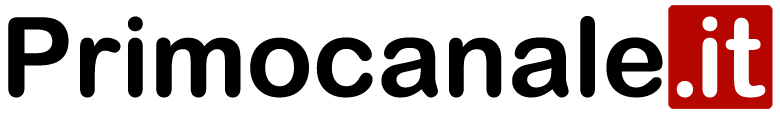
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 05 Gennaio 2026
-
Mario Paternostro
Domenica 04 Gennaio 2026
leggi tutti i commentiIl Casinò di Sanremo, un patrimonio non sfruttato da tutta la Liguria
Quale è la "vocazione" di Genova con Silvia personaggio nazionale?