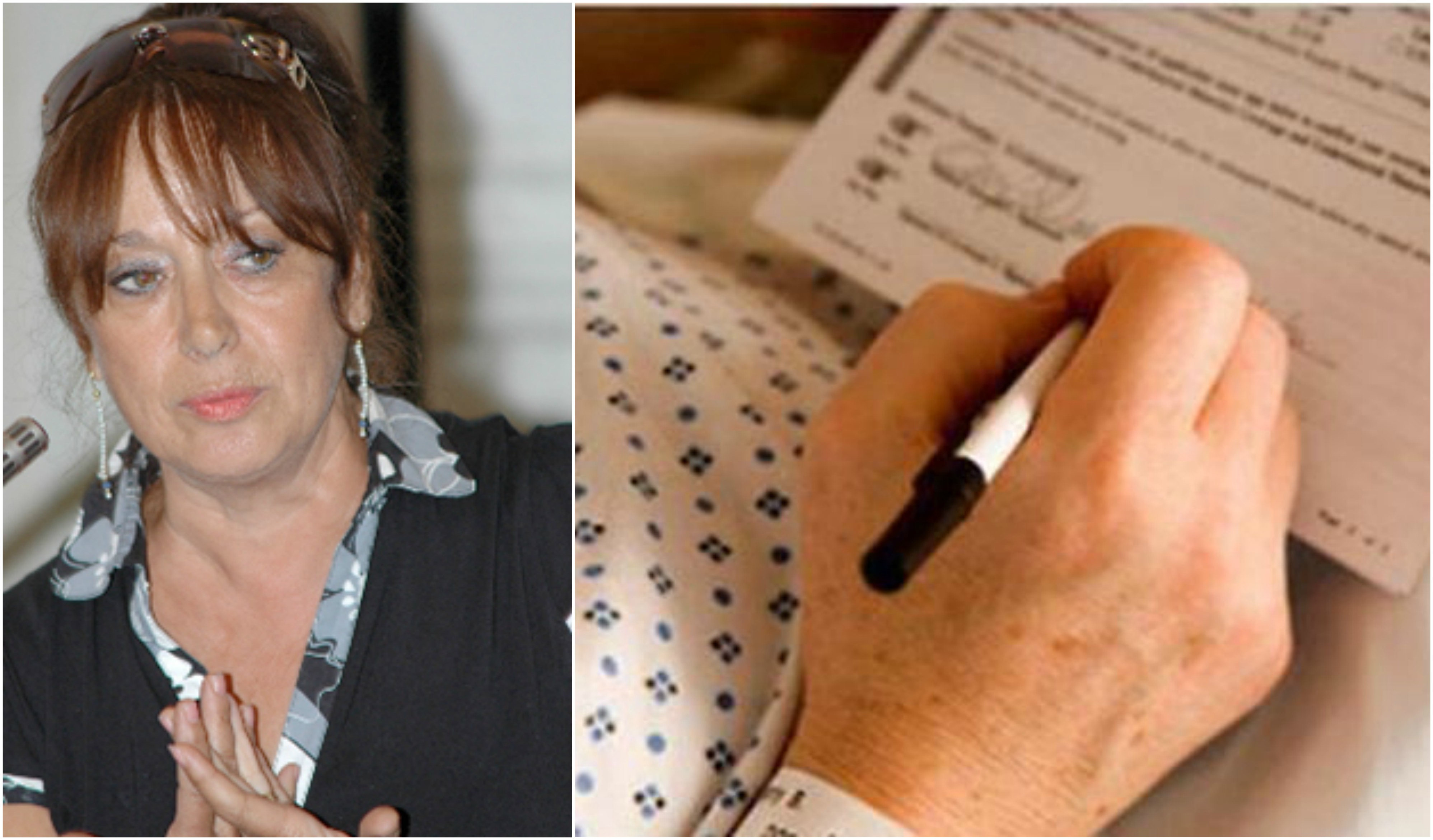 I progressi della biomedicina hanno trasformato, nel giro di pochi decenni, le circostanze e le modalità del morire e insieme hanno contribuito a mutare le visioni della morte. Lo storico francese Philippe Ariès, ne L’uomo e la morte,dal medioevo ai nostri giorni, ha mostrato come gli atteggiamenti verso le ultime fasi della vita siano progressivamente andati mutando e si sia passati, nei secoli, dall’accettazione della morte, vissuta come un evento naturale, a una negazione della morte, propria della società moderna e contemporanea.
I progressi della biomedicina hanno trasformato, nel giro di pochi decenni, le circostanze e le modalità del morire e insieme hanno contribuito a mutare le visioni della morte. Lo storico francese Philippe Ariès, ne L’uomo e la morte,dal medioevo ai nostri giorni, ha mostrato come gli atteggiamenti verso le ultime fasi della vita siano progressivamente andati mutando e si sia passati, nei secoli, dall’accettazione della morte, vissuta come un evento naturale, a una negazione della morte, propria della società moderna e contemporanea.La nascita della bioetica, negli anni settanta, ha posto al centro del dibattito le cosiddette questioni di ‘entrata’ e ‘uscita’ dalla vita, stimolando una progressiva presa di coscienza nei confronti dei problemi connessi al morire. Se la morte è per l’uomo un evento inevitabile, è anche un fatto eminentemente ‘personale’, da assumere coscientemente e responsabilmente, come momento riassuntivo dell’intera esistenza. Da qui deriva la legittimità, anzi la necessità, della cura al morente, il cui principio etico fondamentale si risolve nel favorire la dimensione propriamente umana del morire. Ma da qui anche l’emergere di questioni che riguardano la libertà dell’individuo rispetto al potere medico e i valori di autonomia e di dignità della persona. E’ infatti proprio la capacità della scienza e della tecnologia di ritardare indefinitamente la morte, a far nascere la richiesta di riprendere possesso della propria vita.
Per questo l’approvazione della legge sul biotestamento inaugura una pagina importante nella storia del nostro paese innanzitutto sul piano dei diritti individuali, per l’affermazione del principio del consenso informato attorno a cui ruota la cosiddetta ‘rivoluzione liberale’ in medicina, incentrata sull’idea di autonomia della persona. Ma la legge rappresenta anche, a mio avviso, un decisivo punto di svolta per la convergenza che si è verificata su un tema eticamente sensibile come il fine vita, oggetto di decenni di lotte e di infinite controversie tra opposti schieramenti ideologici.
Per la prima volta abbiamo assistito non all’ennesima guerra di religione tra sostenitori di opposte visioni – come nel caso della legge 40 sulla fecondazione assistita – ma alla responsabile costruzione di un impegno comune e di uno sforzo condiviso di credenti e non credenti. Sappiamo che c’è stata un’attenta valutazione del testo di legge da parte delle gerarchie vaticane e, in questo quadro, di particolare significato sono apparse le parole di papa Francesco, con la sua richiesta di “un supplemento di saggezza perché oggi è insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono effetti potenti sul corpo ma talora non giovano al bene integrale della persona”. Parole che, se richiamano esplicitamente le riflessioni del cardinale Martini a proposito del caso Welby, si collocano perfettamente nella scia dei principi della dottrina cattolica, a partire dalla dichiarazione di Pio XII del 1957 secondo cui “non c’è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente disponibili”. Quello che qui emerge è tuttavia una sensibilità nuova, un forte accento sull’umanizzazione del morire che mette in guardia dal pericolo dell’accanimento terapeutico e sottolinea, nel contempo che “non attivare mezzi sproporzionati o sospenderne l’uso è compiere un’azione che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia”. In tal modo si sono potuti evidenziare i punti di una negoziazione possibile da parte di una politica finalmente sensibile alle richieste personali degli individui e attenta ai loro bisogni esistenziali più profondi. Negoziare è compito assai arduo perché significa impegnarsi per giungere a quello che si chiama “consenso per intersezione”, per cui, pur partendo da prospettive di valore assai diverse, si ritiene tuttavia possibile pervenire ad un nucleo minimo di decisioni su cui si possa ragionevolmente convenire Ecco quindi, in estrema sintesi, quanto la legge ha faticosamente costruito: no all’accanimento terapeutico, al suicidio assistito, all’eutanasia, sì al rispetto dell’autonomia, della dignità della vita biografica e non meramente biologica, alla cura del morente e quindi alle terapie palliative. Punti decisivi su un tema cruciale che ha diviso profondamente lo stesso mondo cattolico al suo interno e che ha provocato – è storia recente – le prese di posizione più integraliste di chi paventava “l’eutanasia mascherata”,” l’eugenetica nazista”, “l’omicidio di stato”. Nulla di tutto questo. In realtà, - occorre ricordarlo? - le dichiarazioni anticipate di trattamento, così come previsto dalla legge, lungi dal comportare alcuna deriva eutanasica, consentono a ciascuno, se lo desidera, in piena libertà e coscienza, di esprimere le proprie volontà circa le cure da ricevere o da respingere, nel caso perdesse la facoltà di decidere a causa di una malattia o di lesioni traumatiche. Una facoltà, dunque, non certo un obbligo. Come ogni testamento, anche quello biologico, è del tutto volontario e può essere sottoscritto se – e solo se – si ritiene che sia preferibile e più saggio prevedere una situazione estrema e fornire indicazioni in merito per evitare sia di affidare ad altri decisioni che dovrebbero riguardare solo la nostra coscienza, sia di gravare parenti e amici della responsabilità non condivisa di decisioni difficili da assumere. Per questo dovremmo salutare con favore una legge seria e civile che si configura come uno strumento giuridico idoneo a regolare situazioni eticamente controverse.
E’ questa una considerazione della massima importanza. Ad un approccio superficiale, il testamento biologico potrebbe infatti suggerire l’idea di una compenetrazione, se non di una identificazione, con l’eutanasia, quasi a significarne una legittimazione. Nulla di più errato. Esulano infatti, dalle direttive anticipate, le dichiarazioni dal contenuto illecito, e quindi vietato, perché contrastanti col diritto, con la deontologia medica etc. Il paziente, per esempio, non può essere in alcun modo legittimato a richiedere la pratica dell’eutanasia in suo favore, una pratica che, com’è noto, è riconducibile nel nostro paese a due distinte ipotesi di reato previste dal Codice Penale: omicidio del consenziente (Art.579) e aiuto al suicidio (Art.580).
Un secondo grave elemento di confusione, spesso evocato nella polemica in corso, è quello per cui si afferma che il testamento biologico rappresenti un abbandono del paziente suggerendo, in tal modo, un contrasto con le cure palliative del dolore. Ancora una volta, va ribadito che le direttive anticipate riguardano qualsiasi tipo di trattamento al quale si desidererebbe essere sottoposti e, quindi, comprendono anche la richiesta di cure palliative, le eventuali disposizioni sul trapianto di organi, le preferenze del soggetto in relazione alle possibilità diagnostiche e terapeutiche, la richiesta della sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale, l’assistenza religiosa etc. Lungi dall’essere un segno di abbandono e di solitudine, il testamento può rappresentare un importante momento di socializzazione del morire, una testimonianza tangibile dell’alleanza terapeutica o dell’antica amicizia, di cui Platone parlava nel Lisia, tra il paziente e il suo medico. Una forma, se si vuole, postmoderna di quell’antica ‘ars moriendi’ che dovrebbe fondarsi sul diritto dell’individuo a morire con dignità.
Mai come oggi c’è bisogno dell’aristotelica fronesis, ovvero di quell’arte della ragion pratica consapevole che i principi ultimi di un sistema morale, pur se enunciati con la massima precisione, non sono in grado di offrire risposte prive di equivoci a tutti i problemi che si pongono gli uomini nell’infinita varietà delle situazioni concrete. Come distinguere il dovere di cura di cura dall’accanimento terapeutico? Rientra nella libertà dell’individuo quella di scegliere se essere sottoposto o meno a certi trattamenti, come la nutrizione artificiale? Quali sono i confini tra atto medico e ordinario sostentamento vitale?
La tesi che la vita umana è un valore indisponibile, indipendentemente dal livello di salute, di percezione della qualità della vita, di autonomia o di capacità di intendere e di volere è un’ affermazione apodittica che contiene, a ben vedere, non poche ambiguità. In effetti, potrei ritenere, senza contraddirmi, che la mia vita sia un valore indisponibile per gli altri, nel senso che nessuno può arrogarsi il diritto di deciderne il valore in base a criteri di utilità sociale o di calcolo economico, ma che sia, invece, disponibile per me, nel senso che mi riservo il potere di decidere se essa valga la pena di essere vissuta, in base ai miei valori di riferimento.
Altra affermazione perentoria, spesso avanzata nella polemica attuale, è quella per cui alimentazione e idratazione artificiale non vadano considerate atti medici ma rientrino nell’ordinaria assistenza. Ciò significa che si tratta di atti dovuti, sottratti, pertanto, alla possibilità di scelta. Facendoli, invece, rientrare - come prevede la legge - tra i trattamenti sanitari, per i quali è necessario il consenso, essi diventano oggetto di opzione della persona la quale ha certo il diritto di essere curata ma anche quello, va ribadito, di non essere tenuta in vita contro la sua volontà e, in ogni caso, dovrebbe poter rifiutare di essere nutrita coattivamente, nello spirito, del resto, di quanto recita il Codice italiano di deontologia medica (art. 51):
<Quando una persona sana di mente rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di alimentazione artificiale>
In singolare contrasto con questa impostazione, verrebbe ritenuta lecita la sospensione della nutrizione artificiale non quando l’individuo dice no, ma solo quando l’organismo rifiuta ogni sostanza. Ancora una volta, allorché ci muoviamo in quello spazio intermedio tra la vita e la morte, in cui l’esistenza si protrae in assenza di una vita cognitiva, l’organismo,e quindi la vita biologica, sembra prevalere sull’individuo e la vita biografica. La scelta pare affidata alle sorti dell’organismo più che all’autonoma volontà della persona: con una caduta paradossale, verrebbe amaramente da aggiungere, nel materialismo e nel vitalismo.
L’innovazione scientifica e tecnologica ha fatto progressivamente venir meno le barriere che la natura poneva alla libertà di scelta sul modo di vivere e di morire. La fisicità della persona era ignorata dai codici: il corpo, in effetti, apparteneva alla ‘natura’. Oggi l’artificialità, che permea sempre più intensamente la nostra vita, consente scelte e decisioni dove prima regnavano il caso e il destino. Da qui la necessità di rimeditare profondamente una strumentazione giuridica costruita in altri climi e per altri obiettivi, a partire innanzitutto dalla riscoperta della trama profonda della nostra Costituzione e di una sua possibile rilettura in chiave bioetica. Una trama etico-filosofica da cui mi sembra emerga con grande nettezza l’affermazione di taluni principi di particolare rilievo per la riflessione bioetica, quali la libertà, la dignità, l’integrità, coniugati in una duplice dimensione, individuale e sociale, indissolubilmente legate. Tutto ormai ruota intorno al consenso della persona, non più oggetto passivo del potere medico, ma soggetto morale e giuridico a pieno titolo, titolare del diritto di stabilire se, come e quando essere – o non essere – curato. La possibilità di scegliere, il principio di autonomia rappresentano ormai nuove dimensioni della nostra libertà; lo stesso diritto di rifiutare le cure non nasce dal vuoto di valori, ma trova le sue radici più profonde in convinzioni religiose – si pensi ai Testimoni di Geova – o morali.
E’ qui fondamentale – come è facile intuire – la relazione col medico che dovrà consigliare e assistere, dando le opportune delucidazioni e offrendo la massima cura : strumento dunque di una comunicazione ritrovata, di una vera e propria ‘alleanza terapeutica, non certo espressione di abbandono, di isolamento o di chiusura. Nella riflessione contemporanea si dà sempre maggiore spazio all’etica della cura, che vuole non soltanto curare ma anche prendersi cura—cioè farsi carico responsabilmente dei bisogni e delle sofferenze della persona. Essa quindi si rivolge soprattutto ai malati ‘incurabili’ e si presenta come una risposta positiva, intesa a contrastare il sentimento di abbandono e la conseguente richiesta di morte da parte dei malati terminali. In questo quadro, si può collocare la crescente diffusione degli hospices, luoghi che mirano a perfezionare il trattamento del dolore e ad accompagnare i pazienti a una ‘buona morte’, in una rinnovata ars moriendi.
‘Prendersi cura’ non significa sempre e solo tenere in vita a ogni costo ma assumersi talora la responsabilità condivisa di accompagnare la vita al suo naturale compimento. Sono qui a confronto due visioni del medico: l’una ‘bellicista’, ben descritta da Susan Sontag ne La malattia come metafora, che lo vede come un generale alla guida di un esercito in guerra contro la malattia, l’altra, riconciliata con l’immagine tradizionale, che lo vede anche come quel nuncius mortis, che accompagna amorevolmente al trapasso, accettandone l’inevitabilità. In linea, quest’ultima, col codice deontologico che ribadisce il dovere del medico di continuare a offrire la propria assistenza morale, limitando la sua opera alla <terapia atta a risparmiare inutili sofferenze> e <fornendo al malato i trattamenti appropriati, a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita> (art. 37).
Ho incontrato nella mia vita malati paralizzati ormai dalla distrofia muscolare progressiva, intenzionati a combattere tenacemente contro la morte, animati da una voglia di vivere inesausta e altri desiderosi di porre fine a un calvario di sofferenze inutili, a un’esistenza avvertita ormai come priva di significato. Se è bene, come taluni hanno sostenuto, che la politica stia lontana da certe decisioni, che esigono primariamente rispetto e solitudine è, tuttavia, suo compito ‘garantire’ quelle condizioni che assicurino a quanti sono liberi di intendere e di volere, di decidere, da sé, se, come e quando morire. Senza esercitare né subire alcuna prevaricazione.
Ma quanti sanno effettivamente che cosa il documento prevede, quali garanzie comporta, quali limiti si assegna? L’assenza di informazione è tanto più sconcertante ove si consideri che mentre i normali testamenti riguardano i nostri beni materiali, il testamento biologico riguarda il nostro bene più prezioso e indisponibile: la vita stessa. Le direttive anticipate, con la loro valorizzazione dell’autonomia della persona –protagonista della decisione terapeutica - rappresentano certo un’estensione della cultura che ha introdotto il modello del ‘consenso informato’. Si potrebbe vedere in esse una sorta di ‘pianificazione anticipata delle cure’ anche se, a mio avviso, si propongono qualcosa di più delicato e importante: rendere possibile un rapporto personale tra medico e paziente proprio in quelle situazioni in cui si incontrano drammaticamente la solitudine di chi non può più esprimersi e quella di chi deve decidere. La loro finalità fondamentale è di fornire ai medici, al personale sanitario e ai familiari informazioni che li aiutino a prendere decisioni che siano sempre in sintonia con la volontà e le preferenze della persona da curare. Per questo è auspicabile che abbiano carattere pubblico, cioè siano redatte in forma scritta, da soggetti maggiorenni, competenti, informati, non sottoposti ad alcuna pressione familiare, ambientale, sociale e che siano tali da garantire la massima personalizzazione e la possibilità di revoca in qualsiasi momento. Indispensabile appare ovviamente l’informazione adeguata e dettagliata relativamente alle situazioni cliniche e alle conseguenze che può comportare la somministrazione o l’omissione dei vari trattamenti. L’assistenza di un medico che le controfirmi consente di non lasciare equivoci sul loro contenuto; così pure la nomina di un ‘fiduciario’- designato dallo stesso paziente - col compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle direttive e di intervenire a tutela degli interessi e dei desideri precedentemente espressi, qualora sorgessero dubbi sull’interpretazione o sull’attualità di tali desideri.
Come si vede, le direttive anticipate, nella ricchezza delle loro articolazioni, possono considerarsi parte del lungo cammino volto a assicurare il rispetto della dignità del malato. Un cammino tutt’altro che concluso: è probabile infatti che debba passare ancora molto tempo perchè i principi ispiratori che le animano riescano a modellare il comune modo di pensare dei medici, dei pazienti e più in generale della pubblica opinione. Per questo è importante continuare a discutere nelle scuole, negli ospedali, nelle associazioni, nella consapevolezza della straordinaria complessità della questione che dobbiamo affrontare. Un esempio? Il fatto che spesso la consapevole rinuncia da parte del paziente al cosiddetto ‘accanimento terapeutico’ venga ancora indebitamente confusa con l’eutanasia complica notevolmente il discorso sul testamento biologico, in cui si afferma unicamente il diritto di chiedere la sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche che il paziente competente ha il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare. Né –altro punto controverso--il testamento sembra apparire in contrasto col principio della sacralità della vita: ciascuno è responsabile della sua vita e della sua morte, sia che consideri la vita come un dono divino, sia che la veda come un personale possesso.
Il cardinale Martini, nel suo pacato intervento sul caso Welby, ricordava che evitare l’accanimento terapeutico significa assumere i limiti della propria condizione mortale. Ma come stabilire—si chiedeva —se un intervento medico è appropriato? Non ci si può richiamare a una regola generale, quasi matematica, da cui dedurre il comportamento adeguato ma occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, la situazione in cui l’evento si svolge. Si tratta di un rilievo della massima importanza che ci richiama a una visione della morale non come dominio non della legge astratta e dei principi assoluti ma come luogo della prudenza, secondo una tradizione che risale ad Aristotele e di cui Tommaso, nel pensiero cristiano, dà testimonianza. In bioetica non s’intende tanto dimostrare una verità quanto giustificare una scelta, un’adesione, una pratica; la giustificazione riguarda la legittimità, la moralità ma anche l’opportunità di un determinato agire. Che cosa rende un corso d’azione migliore d’un altro, una decisione più giusta di un’altra? I principi non possono mai decidere le questioni etiche per se stesse ma, piuttosto, possiamo cogliere la forza morale dei principi studiando i modi in cui essi sono applicati alle situazioni particolari.
Per una valutazione della proporzionalità, Martini - come oggi Bergoglio -faceva riferimento, oltre che alla situazione, alla volontà del malato e, dunque, alla centralità della persona: la proporzionalità deve essere calibrata su un soggetto, meglio, da lui decisa, non affidata ad astratte valutazioni. Non si vuole così ridurre o ridimensionare il ruolo del medico, come taluni potrebbero temere, ma piuttosto ricostituire una relazione col malato, una vera ‘alleanza terapeutica’, basata sulla comunicazione e, quindi, sulla fiducia.
Da questi interventi mi sembra emerga, pertanto, la possibilità di una bioetica religiosa che riconosca il valore cruciale dell’autonomia, un valore che spesso si considera proprio soltanto di una bioetica laica. Un’autonomia da intendersi in senso forte, kantiano, intesa a fare di ciascuno di noi il legislatore tenuto a osservare la sola norma che deriva dalla ragione; un’autonomia che non è assoluta, non significando, secondo una visione stereotipata, né isolamento né abbandono, e nemmeno uno ‘stato’ ma, piuttosto, un processo, qualcosa che matura e si rafforza nel dialogo tra medico e paziente. Perchè mai un credente non dovrebbe preoccuparsi della modalità della sua morte, riflettere su quali decisioni prendere in situazioni che si prospettano dilemmatiche, dal momento che a buon diritto si preoccupa della sua salute nel corso della vita? La fede nella provvidenza divina non esclude in alcun modo la lungimiranza umana: probabilmente la presuppone. Viene inoltre mostrata la compatibilità tra ‘autonomia e ‘cura’, due valori spesso ritenuti erroneamente antagonisti. In realtà, all’interno di una bioetica liberale, che ponga al centro la relazione tra l’io e il tu, l’autonomia non esclude in alcun modo quel <prendersi cura> che significa attenzione per l’altro, le sue esigenze, i suoi bisogni e che testimonia una solidarietà umana fondamentale.
Sono certo comprensibili e ampiamente condivisibili le cautele procedurali relative all’accompagnamento al morire, proprio per evitare che prendano il sopravvento interessi diversi da quelli del morente(es. l’istituzione ospedaliera che vuole ridurre i costi di degenza; famiglie o congiunti che vogliono liberarsi da oneri divenuti troppo gravosi etc.). La disciplina giuridica deve rimanere sempre saldamente ancorata alla volontà espressa dalla persona e, proprio per questo, l’impegno a favore del testamento biologico dovrebbe essere sostenuto da credenti e non credenti.
Un impegno comune volto a elaborare regole per conciliare il diritto individuale a disporre della propria vita—peraltro costituzionalmente garantito—con l’obbligo istituzionale a favorire tutte le cure necessarie alla persona malata, obbligo che non si deve in alcun modo spingere alla ‘tortura inutile’ dell’accanimento terapeutico.
Casi recenti hanno rotto la congiura del silenzio sulla morte, costringendoci a parlare di che cosa è--e sarà sempre più--lo stato terminale della vita, il tratto estremo del nostro passaggio umano in società tecnologiche ad alta medicalizzazione. La tecnica sta ormai cancellando la morte naturale nei termini in cui l’aveva finora vissuta la nostra specie. Viviamo un mutamento epocale che richiede un esercizio straordinario di ragione e di realismo proprio per un carico di decisioni e di responsabilità impensabili nel mondo di ieri, governato dalla natura e dalle sue leggi.
La questione delle direttive anticipate di trattamento, che rischia ancora oggi di trasformarsi in una occasione di scontro ideologico tra sostenitori di opposte visioni ,dovrà diventare oggetto di una discussione parlamentare serena, basata sull’assunzione di alcuni dati di fatto sulle decisioni di fine vita, a partire dalla Convenzione di Oviedo (1997), oltre che dal Codice di Deontologia medica, in cui si ribadisce che il medico “non può non tener conto delle eventuali dichiarazioni di volontà precedentemente espresse”.
Vicende tragiche come quella di Giorgio Welby e di Eluana Englaro ci hanno fatto comprendere le mutue implicazioni tra la sfera della politica e quella della vita, tra polis e bios. Lo sviluppo tecnologico è talmente rapido da rendere sempre più labili le frontiere tra la vita artificiale e la morte. Problemi privati, da risolvere nel foro interiore, sono ormai entrati nel campo politico: ciò che era ai confini sta ora al centro. Dalla bioetica siamo passati così alla biopolitica, la quale presenta un’ambivalenza fondamentale: ha una faccia autoritaria, quella con cui lo stato vuole ingerirsi a tutti i costi nella privacy, entrando nelle decisioni più intime e dolorose relative al nascere e al morire; ma ve n’è un’altra liberale per cui la scienza può e deve diventare un’alleata dell’individuo, che resta il protagonista delle sue scelte, non un avversario da temere o da combattere. Sta a noi far sì che questa biopolitica prevalga sull’altra.
*Luisella Battaglia - Professoressa ordinaria di filosofia morale e bioetica all'Università di Genova e al Suor Orsola Benincasa di Napoli; membro del comitato nazionale di bioetica del Consiglio dei ministri.
 10° C
10° C LIVE
LIVE

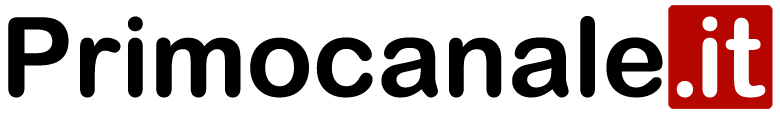
IL COMMENTO
-
Franco Manzitti
Sabato 27 Dicembre 2025
-
Matteo Angeli
Giovedì 25 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiLa litania di Genova targata 2026 tra acciaio e porto
Il Natale della comunità: l'impegno di Primocanale e gli auguri della redazione