 “Rispetto al 2012, non si rilevano progressi rilevanti nel percorso di avanzamento lungo il tunnel della crisi: tranne che per il comparto dei servizi alle persone, il trend di tutti gli altri comparti registra un peggioramento”. Lo scrive la Confartigianato Liguria nel suo “Rating di mandato 2010-2015” in cui dà i voti al quinquennio dell’amministrazione regionale guidata da Claudio Burlando. E dal canto suo, il Centro Studi di Unioncamere fotografa in Liguria “un tasso di disoccupazione pari al 10,8%”, il peggiore del Nord con la sola eccezione del Piemonte, e “un tasso di disoccupazione giovanile al 45%, contro il 42,7% della media nazionale”.
“Rispetto al 2012, non si rilevano progressi rilevanti nel percorso di avanzamento lungo il tunnel della crisi: tranne che per il comparto dei servizi alle persone, il trend di tutti gli altri comparti registra un peggioramento”. Lo scrive la Confartigianato Liguria nel suo “Rating di mandato 2010-2015” in cui dà i voti al quinquennio dell’amministrazione regionale guidata da Claudio Burlando. E dal canto suo, il Centro Studi di Unioncamere fotografa in Liguria “un tasso di disoccupazione pari al 10,8%”, il peggiore del Nord con la sola eccezione del Piemonte, e “un tasso di disoccupazione giovanile al 45%, contro il 42,7% della media nazionale”.Bastano queste rilevazioni, non dissimili a quelle di altre organizzazioni, per capire che se l’Istat annuncia l’uscita dell’Italia dalla recessione, il vagone chiamato Liguria dev’essersi sganciato dal resto del treno. Ma poi, è davvero così? La crescita del Pil pari allo 0,3% certificata nel primo trimestre di quest’anno è stata lanciata dall’Istituto di Statistica e accolta dal governo con un’enfasi probabilmente degna di miglior causa. Per carità, il segno più è meglio del segno meno, alcuni affidabili analisti economici del mondo bancario dicono che “può essere un’importante inversione della tendenza”, ma essi stessi si affrettano a chiarire: “E’ presto per dire che la crisi è alle spalle”. Del resto, è stato recuperato solo lo 0,3% di oltre il 9% di Pil andato al macero in questi anni. Una goccia nel mare.
In un clima arroventato dalla campagna elettorale è chiaro che ogni cifra è buona per dire che chi comanda sta facendo bene e Matteo Renzi, il premier, non sfugge a questa regola. Tutti concordano, però, sul fatto che solo il dato sull’occupazione è la vera cartina di tornasole di una ripresa concreta e qui il rosario delle cifre si sgrana secondo la solita, allarmante litania. Ma poiché ogni istituzione raccoglie e analizza i dati secondo propri criteri, ci troviamo di fronte a un florilegio di stime che in realtà vengono piegate alla “bisogna” della politica. E’ un po’ come per i sondaggi elettorali, tanto per intenderci: a seconda di chi li commissiona, danno un risultato del candidato del committente migliore. Non è un caso se entro fine mese il ministro dell’Economia Piercarlo Padoan s’è deciso a convocare Istat, Inps e Ministero del Lavoro per armonizzare i criteri con cui si fotografa la situazione: per avere un’istantanea credibile (e utile allo stesso governo, al di là della propaganda) e non una serie di istantanee sfuocate, sebbene imbellettate dai ritocchini del fotoshop.
E’ vero che l’economia e la finanza si nutrono anche di aspetti psicologici e una “buona notizia” comunque aiuta, ma quel +0,3% del Pil segnato nel primo trimestre 2015 va maneggiato con cura, sottraendosi aglii entusiasmi. I problemi c’erano e rimangono, in tutta la loro gravità. Del resto, che cosa significa quel dato? E’ così piccolino che potrebbe essere bastato l’incremento della produzione Fiat a Melfi a crearlo, oppure hanno concorso la liquidità immessa sul mercato dalla Banca centrale europea (Bce), i tassi di interesse addirittura negativi, il basso prezzo del petrolio. Per stare a quest’ultimo elemento: intanto il barile è risalito da 50 a 60 dollari, che cosa succederebbe se il greggio dovesse impennarsi? E quel +0,3% del Pil sarebbe possibile se l’oro nero fosse rimasto in queste settimane su livelli più elevati?
Qui non si tratta di andare a infoltire la schiera di coloro che Renzi definisce “gufi”, bisogna solo avere la consapevolezza che non è con una crescita dello “zero virgola” che si può recuperare la solidità economica perduta e guardare con più fiducia al futuro. Quando il ministro Padoan dice che “centrare il +0,7% stimato per quest’anno ora è più facile” compie una proiezione probabilmente vera dal punto di vista statistico-numerico, ma il punto centrale è invariato: quella crescita sarà figlia delle condizioni generali favorevoli, ma congiunturali, o comincerà ad avere come propellente un’azione di governo finalmente capace di indirizzare l’Italia lungo il percorso di un preciso modello di sviluppo? La risposta ancora non c’è. Per una semplice ragione: questo modello di sviluppo non si vede, né nelle linee generali, men che mai nei particolari. Inoltre, ci portiamo dietro il pesante fardello di un debito pubblico al 130% del Pil: “La vera sfida è questa” ci ha fatto sapere solo pochi giorni fa il Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici. Appunto: se non ci fosse l’economia sommersa, l’Italia sarebbe già saltata per aria. Ma siamo in Europa e in un contesto di economia globalizzata: per quanto tempo ancora la settima, ottava, nona o decima potenza industriale del pianeta (neppure la nostra posizione, ormai, si capisce quale sia) potrà fondarsi sull’illegalità diffusa?
 11° C
11° C LIVE
LIVE

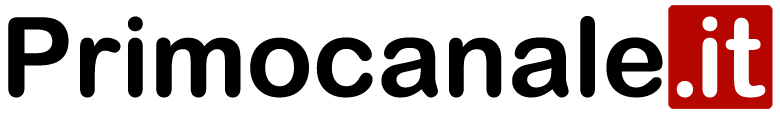
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 21 Dicembre 2025
-
Franco Manzitti
Sabato 20 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiAddio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria
La svolta dell'arcivescovo Tasca dalle parrocchie al cuore della città