 Il 15 agosto dell’anno scorso, piazzati sul ponte di Campi, i giornalisti di tutto il mondo chiedevano ai loro cameraman la stessa cosa: “Inquadra il moncone est del Morandi, può crollare sulle case da un momento all’altro”. Sotto un sole cocente che si era sostituito al diluvio del giorno prima, le notizie su vibrazioni di assestamento e piccoli abbassamenti di quel pezzo di ponte a strapiombo sulle case si rincorrevano incessanti. Nessuno aveva il permesso di avvicinarsi, il pericolo era al massimo grado.
Il 15 agosto dell’anno scorso, piazzati sul ponte di Campi, i giornalisti di tutto il mondo chiedevano ai loro cameraman la stessa cosa: “Inquadra il moncone est del Morandi, può crollare sulle case da un momento all’altro”. Sotto un sole cocente che si era sostituito al diluvio del giorno prima, le notizie su vibrazioni di assestamento e piccoli abbassamenti di quel pezzo di ponte a strapiombo sulle case si rincorrevano incessanti. Nessuno aveva il permesso di avvicinarsi, il pericolo era al massimo grado.Per una fortunata e probabilmente miracolosa serie di coincidenze, quel moncone slabbrato e stanco ha resistito sopra i tetti di via Porro per trecentodiciotto lunghissimi giorni, fin quando l’esplosivo lo ha fatto crollare per sempre, come un castello di carte.
Eppure fragile, come un Asso e un Kappa messi per gioco a piramide dopo un pranzo estivo, quel ponte lo era davvero: auto dopo auto, camion dopo camion la lunga lingua d’asfalto sormontata da inadeguati pinnacoli e sorretta da vecchi piloni non ce l’ha fatta più e si accasciata nel Polcevera. Sopra, con il sorriso stampato sulla via delle vacanze, c’erano 43 persone che oggi sono un fiore su una lapide.
Ma guardandolo cadere, quel moncone attaccato alla collina profumava ancora di miracolo: “Com’è possibile – quante volte ce lo siamo chiesti – che il crollo abbia risparmiato proprio le case di via Porro”?
Ed è disegnando lo scenario B, quello che poteva essere e non è stato, che ci si accorge di quanto incredibile sia stato il rischio che quel ponte ha fatto correre a un’intera comunità: cosa sarebbe successo se quel vecchio moncone non avesse sopportato lo sforzo immane di negare le leggi della fisica? Cosa sarebbe successo se il Morandi fosse precipitato sui palazzi, in una sonnolenta e piovosa mattina d’agosto?
Intrappolati a letto, sul divano, davanti a un caffè di metà mattina, le donne e gli uomini che abbiamo conosciuti in questi mesi sotto le Ratelle o in via Capello sarebbero stati altri fiori, altre lapidi. Centinaia di fiori e lapidi. Il boato delle pile che si sbriciolano, il tremore di un terremoto umano si sarebbero accompagnati ad altri boati, ad altri terremoti: i condomini dei ferrovieri si sarebbero piegati sotto il peso di camion, asfalto, cemento armato. Dentro, gli appartamenti si sarebbero trasformati in loculi, intonaci e mattoni senza vita, senza respiro.
E se invece di un martedì di pioggia fosse stata una soleggiata vigilia di Ferragosto? O un normale martedì di lavoro, con centinaia di auto e mezzi pesanti bloccati in coda?
Dobbiamo dunque festeggiare per la mancata ecatombe? No davvero. Ma dobbiamo avere il coraggio di conferire ai fatti del 14 agosto 2018 il giusto posto nel mondo: un’immane tragedia, ben più grande e terribile di quanto si possa ammettere o immaginare.
E’ per questo che Primocanale, mentre Autostrade per l’Italia inviava alla stampa comunicati che sembravano i libretti delle giustificazioni di uno scolaro svogliato, aveva coniato lo slogan “Tacete!”. Perché il silenzio era l’unica risposta possibile e accettabile.
Oggi, dieci mesi dopo, sepolti i cadaveri, gestiti gli sfollati e scombinato vita e affari a decine di migliaia di persone, si torna a parlare di “concessioni autostradali”: il governo, il vicepremier Luigi Di Maio in particolare, continua a chiedere la revoca della concessione alla società guidata dalla famiglia Benetton, considerando “grave inadempienza” ciò che è avvenuto a Genova.
Non credo sia necessaria la raffinatezza di un giurista per distinguere una bagatella da una tragedia, è evidente a tutti che l’inadempienza genovese non sia stata grave ma gravissima, incommensurabile, pazzesca. E che se la revoca di una concessione non è possibile di fronte a un simile disastro allora non sarebbe possibile mai.
Il tribunale deve fare il suo corso, la giustizia deve individuare precisi responsabili e determinare le pene: ma la politica ha un compito diverso. Il governo deve aiutarmi a non avere più paura, ogni volta che con l’auto imbocco un ponte. Deve convincermi che posso ancora avere fiducia nelle opere pubbliche, che posso ancora fidarmi di tecnici, ingegneri, grandi società.
La concessione non è solo un contratto: ad Autostrade per l’Italia era stata affidata la nostra sicurezza, la nostra vita. Guardate che fine ha fatto il nostro ponte, guardate dove sono oggi quelle vite. Revocare quella concessione è il minimo che noi, tutti noi che sopra e sotto il ponte siamo passati mille volte rischiando di non tornare a casa, ci aspettiamo come minimo risarcimento.
 17° C
17° C LIVE
LIVE

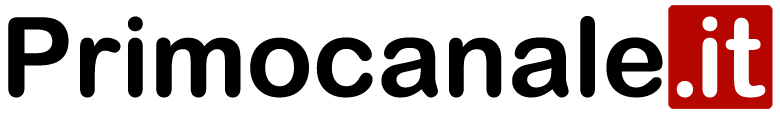
IL COMMENTO
-
Stefano Schiaparelli*
Mercoledì 12 Novembre 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 10 Novembre 2025
leggi tutti i commenti40 anni di ricerche italiane in Antartide, la prima partì da Genova
Dalla gigafactory di Genova a Urso, Brunetta & C: Meloni ha un problema