
Per tre anni, la riqualificazione post-scolmatore della Valbisagno è stato il tema del Laboratorio che tenevo nel Politecnico di Milano. I gruppi di lavoro, tutti giovani alle soglie della laurea, presentarono una trentina di progetti. Molti puntarono sulla migliore distribuzione delle funzioni e delle attività urbane. E, partendo da questo, proposero vari modelli di mobilità. Alla fine, nessuno dei progetti inserì una linea metropolitana. Quasi tutti disegnarono tram o, più raramente filobus o affini, nelle più diverse declinazioni.
Da almeno 70 anni, Genova insegue ostinatamente il sogno della metropolitana. Il primo, rudimentale studio lo vidi sul tavolo di casa quando avevo 12 anni o giù di lì. L’idea progettuale seguita da mio padre, tranviere, proponeva già allora l’uso della galleria tranviaria di Certosa, assieme alla riqualificazione di alcune gallerie ferroviarie abbandonate. Più tardi la metropolitana genovese sorse tra mille difficoltà, fino all’attuale sviluppo di sette chilometri e nove stazioni, Corvetto compresa. Ci vollero 39 anni di lavoro, dal 1986 a oggi (e domani).
Per disattenzione, mi è sfuggita la pubblicazione dei dati oggettivi che sostengono tuttora questo sogno. Un’araba fenice che rinasce periodicamente come il Ponte sullo Stretto. E l’Intelligenza Artificiale fornisce qualche dato di massima. La metropolitana di Genova —contenuta non solo come estensione ma anche dimensione delle carrozze, una metropolitina— trasporta ogni giorno circa 40mila passeggeri con 9 stazioni, meno di 5mila per ogni fermata, meno di 6mila per ogni chilometro di linea. Sono numeri che sostengono questo modello di mobilità urbana? Sono meno dei 6mila passeggeri che trasporta ogni giorno la tranvia T1 a Firenze.
Non esistono valori “universali”, sia ottimali sia validi per tutte le città. I numeri ideali di passeggeri dipendono da molti fattori: densità urbana, frequenza dei treni, capacità delle stazioni, modello di servizio, e domanda locale. Tuttavia, i pianificatori si rifanno a intervalli di riferimento con cui gli esperti di trasporto pubblico valutano l’efficienza e la sostenibilità di una linea metropolitana.
Le linee metropolitane di successo nelle grandi città europee e asiatiche trasportano da 15mila a 30mila passeggeri al giorno per ogni chilometro di linea. Per esempio, la linea rossa di Milano (M1) trasporta circa 362mila passeggeri al giorno lungo 27 km, cioè più di 13mila passeggeri al giorno per chilometro. E, pur attraversando il centro cittadino, la M1 serve anche periferie a modesta densità urbana. Valori superiori a 10mila passeggeri/giorno/km sono già considerati buoni per una città europea di medie dimensioni, anche se le metropolitane più affollate del mondo —per esempio, Tokyo o Parigi—superano la soglia di 30-40mila passeggeri/giorno/km.
Un valore di riferimento per una metro efficiente è compreso tra 10 e 20mila passeggeri al giorno per fermata. La linea rossa di Milano, con 39 stazioni, trasporta tra 9 e 10mila passeggeri al giorno per fermata, ma nel periodo pre-pandemia questo parametro era ben più alto, quasi 13mila. Valori sopra i 10mila passeggeri/giorno/fermata indicano una buona saturazione della linea, sotto i 5mila si parla di linee sottoutilizzate, mentre sopra i 20mila si rischia il sovraffollamento.
Forse i miei studenti di architettura e urbanistica, quasi tutti stranieri, avevano ragionato con questo metro (scusate il bisticcio) molto rudimentale per giustificare le loro scelte di mobilità veloce ma non rapida. E soprattutto dolce. Forse li avevo involontariamente influenzati, per via dei ricordi d’infanzia, quando i tram risalivano le pendici fino alla Circonvallazione, disegnando tracciati affascinanti, paragonabili solo a quelli di San Francisco e Lisbona, Vienna e Praga.
I numeri che ho dato sono assolutamente grossolani, né sono un esperto di mobilità ma solo un idraulico. Mi cospargo in anticipo il capo di cenere. Volevo solo capire perché nessun mio allievo prese in considerazione la soluzione finale che la maggioranza dei genovesi ha nel cuore. Se non i numeri, almeno gli ordini di grandezza dovrebbero far riflettere sui modelli che Genova insegue in molti campi, qualche volta senza valutare appieno le proprie peculiarità.
Sono di parte, lo confesso. Per mio padre, che dirigeva la Officina Guglielmetti di Uite/Amt, la morte dei tram fu l’antipasto della malattia che lo portò via a 59 anni. E, tra i ricordi più vivi, c’è la breve fuga in tram che feci da bambino. Dopo essermi arrampicato sullo sgabello di una vettura Genova in sosta al capolinea di Piazza Terralba, avevo ruotato il manipolatore. Il tram partì a discreta velocità, una gioia e una ebbrezza indescrivibili. Fui bloccato poco prima di Piazza Martinez, quando il bigliettaio riuscì a saltare in vettura dopo un trafelato inseguimento. Altri tempi: c’era ancora il bigliettaio.
Renzo Rosso, professore ordinario di Idrologia e Costruzioni Idrauliche al Politecnico di Milano
 8° C
8° C LIVE
LIVE
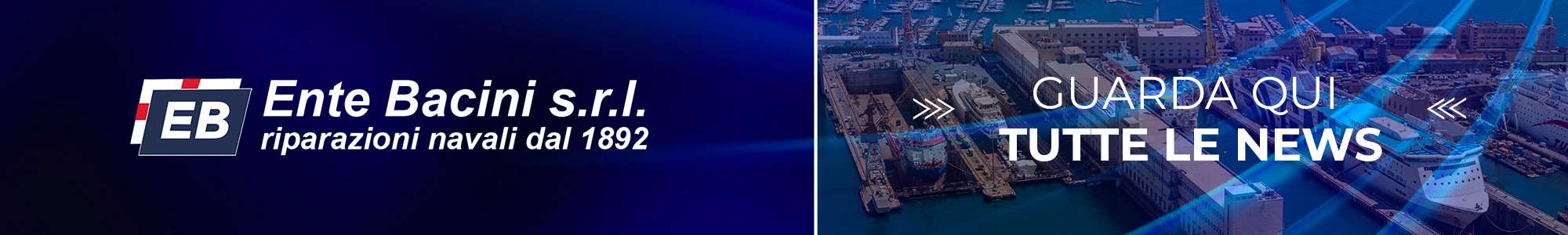

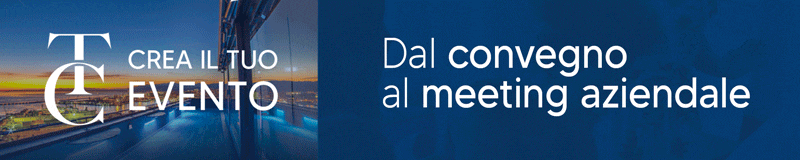
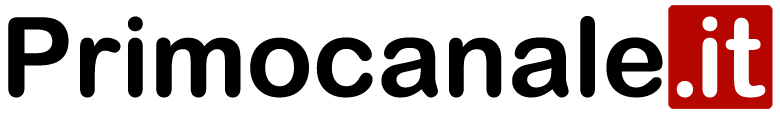
IL COMMENTO
-
La redazione
Venerdì 02 Gennaio 2026
-
Matteo Angeli
Giovedì 01 Gennaio 2026
leggi tutti i commentiAl 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè
Buon anno di cuore a tutti i nostri lettori