Giovedì 23 Febbraio 2023
Il centro storico di Genova è il luogo più bello del mondo!
I problemi non mancano, certo, ma il fascino che emana non ha eguali
Mercoledì 22 Febbraio 2023
Ottantotto passi
Il fascino del centro storico svanisce con il passare degli anni, per un suo abitante che ne fu innamorato
Martedì 21 Febbraio 2023
Primocanale a Romei: "Ecco perché non si trova un acquirente"
Caro avvocato Romei, le spieghiamo noi perché è difficile trovare un acquirente per la Sampdoria: 1) La società ha un indebitamento forte, scenario forse non peggiore rispetto ad altri club di serie A ma complicato dalla molteplicità dei creditori: fisco, banche, agenti, fornitori. Tutti i soggetti...
Lunedì 20 Febbraio 2023
Superbonus non fa rima con certezza e credibilità
Non sono una novità, l'Italia è da tempo il Paese del "nessuna certezza". Le periodiche riforme delle pensioni sono lì a testimoniarlo, con diritti acquisiti che non lo sono affatto e con misure che traguardano solo il consenso a brevissima scadenza
Domenica 19 Febbraio 2023
Evviva il carnevale della Maddalena fa rivivere la città da non abbandonare
La celebrazione del Carnevale fortemente voluta dal Comune è stata un indiscutibile successo di gente. Genova, in questi giorni, mi è parsa particolarmente piena, in movimento, divertente. Insomma una città che sa finalmente accogliere, dove la famosa e emblematica torta di riso sempre finita, è sta...
Sabato 18 Febbraio 2023
Mecenatismo, beneficenza, business, ma Genova non "strippava" di soldi?
Non è il caso di sgranare il rosario delle aziende di ogni tipo e settore economico, che sono state vendute dai genovesi con contropartite stellari
Venerdì 17 Febbraio 2023
Se in fila per un fiore ci sono anche i ragazzini
La foto di uomini e giovani in fila per acquistare un mazzo di fiori la sera di San Valentino davanti a un fioraio nel cuore di Genova è subito diventata virale.Normale, non capita spesso di assistere a una fila di uomini per comprare non il nuovo smartphone o un biglietto per una partita di calcio ...
Giovedì 16 Febbraio 2023
Auto, corsa all'elettrico: rischiamo di buttare miliardi per niente
Fissata la data per l'addio ai motori termici, 2035: ma l'Europa non è pronta
Mercoledì 15 Febbraio 2023
Quando il viceministro ai Trasporti è bloccato in autostrada in diretta tv
Succede che il viceministro ai Trasporti rimanga bloccato in coda per ore. Nessun lampeggiante blu, nessuna scorciatoia. Edoardo Rixi con il suo furgone di ritorno da una gita domenicale è restato intrappolato sulla A 10 per colpa dei "tradizionali" lavori" che da troppi anni fanno parte del paesagg...
Martedì 14 Febbraio 2023
Elezioni, l'astensionismo che fa paura e l'avviso al centrodestra per Imperia
La verità è che c'è un Paese che parla con Amadeus, il re del Festival di Sanremo, e non parla più con la politica. La quale dimostra di essere lontana anni luce dai veri problemi delle personeVenti minuti Salis-Salvini: un blitz con troppi dubbi
Sabato 09 Agosto 2025
Vi racconto la magia del concerto dei Beatles a Genova: "Io c'ero"
Giovedì 26 Giugno 2025
Maturità: nelle tracce mancata l'attualità controversa, dall'Ucraina alla Palestina
Venerdì 20 Giugno 2025
Il futuro della nostra lingua scritto nel tema della maturità
Giovedì 19 Giugno 2025
Notizie più viste
Contro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Una ricerca attenta alle differenze di genere per generare equità
Martedì 21 Ottobre 2025
Bucci e le Asl, le multe a Imperia: ignorati il merito e le regole
Lunedì 20 Ottobre 2025
Nel "Waterstop" monomarca si mangeranno solo besughi
Domenica 19 Ottobre 2025
Ultime notizie
-
Tumore al seno under 40, 100 visite di screening al San Martino: "Serve più informazione"
- Oggi è il World Pasta Day: 1 italiano su 2 la mangia ogni giorno
- Ora legale, con l'energia risparmiata in Liguria si può alimentare Recco per un anno
- Genova, dal 2026 potrebbero chiudere impalcati e ponti: ecco perché
- Lancette indietro di un'ora, questa notte ritorna l'ora solare
-
25 ottobre 2011: la più grande alluvione della storia delle Cinque Terre
 13° C
13° C LIVE
LIVE














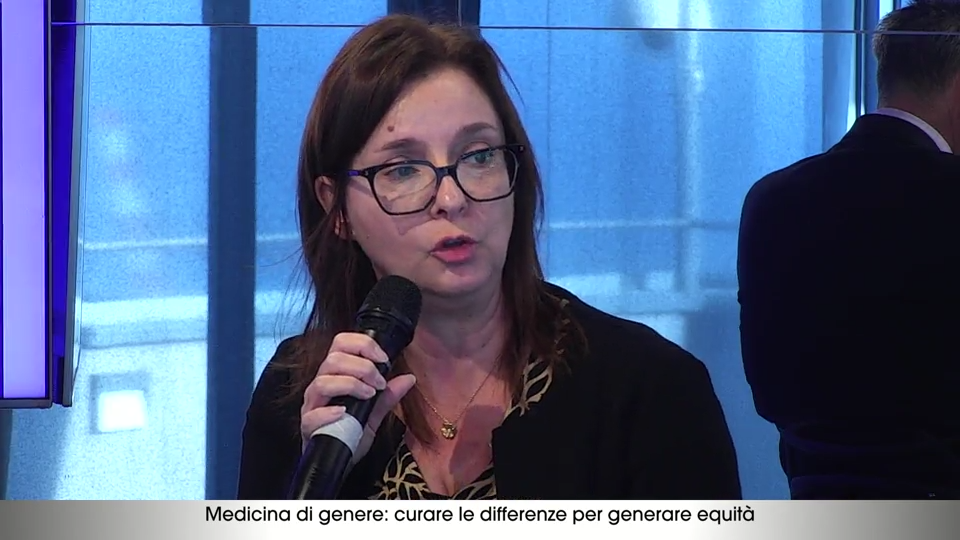





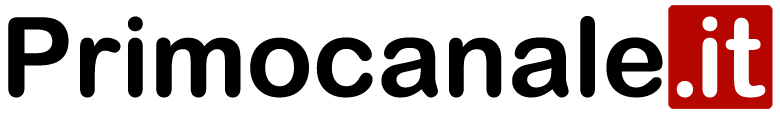
IL COMMENTO
-
Giulia Panizza*
Mercoledì 22 Ottobre 2025
-
Rita Banzi*
Martedì 21 Ottobre 2025
leggi tutti i commentiContro il cancro pediatrico non dimenticate l'umanità
Una ricerca attenta alle differenze di genere per generare equità