 Ci sono due momenti topici a marcare l’esito delle elezioni regionali in Liguria. Il primo: nel negoziato nazionale, Silvio Berlusconi cala sul tavolo l’asso della candidatura di Giovanni Toti, il suo consigliere politico, anche se la Lega ha già in campo il suo uomo di punta, Edoardo Rixi, che è pure il vice del leader, Matteo Salvini. Sembra che debbano volare gli stracci, invece accade che Rixi faccia un passo indietro: “Mi sacrifico in nome dell’unità del centrodestra”. Toti completa il “miracolo” di ricompattare l’area, riesumando per una volta quello che fu il Pdl (più il Carroccio).
Ci sono due momenti topici a marcare l’esito delle elezioni regionali in Liguria. Il primo: nel negoziato nazionale, Silvio Berlusconi cala sul tavolo l’asso della candidatura di Giovanni Toti, il suo consigliere politico, anche se la Lega ha già in campo il suo uomo di punta, Edoardo Rixi, che è pure il vice del leader, Matteo Salvini. Sembra che debbano volare gli stracci, invece accade che Rixi faccia un passo indietro: “Mi sacrifico in nome dell’unità del centrodestra”. Toti completa il “miracolo” di ricompattare l’area, riesumando per una volta quello che fu il Pdl (più il Carroccio). Il secondo momento topico è quando Raffaella Paita riceve l’avviso di garanzia per l’alluvione del 9-10 ottobre 2014: neppure di fronte a questo traumatico evento si fa da parte. Né le viene chiesto dai vertici del partito, siano quelli regionali o nazionali. Non bastassero il pasticcio delle primarie e gli strappi a sinistra, la parola d’ordine è una e una soltanto: “Si va avanti e vinciamo”.
La morale di questi due momenti, scolpita disvelando il segreto delle urne, è semplice: l’umiltà sconfigge l’arroganza. Io credo che si debba cominciare da qui per provare a capire il dipanarsi delle ultime concitate ore. Prendendo atto, però, che Toti e il centrodestra hanno vinto in proprio e in proprio hanno perduto Paita e il Pd.
Non so dire come l’uomo di Ameglia governerà la Liguria. Forse comincerà a pensarci da oggi, perché, al di là delle dichiarazioni pubbliche, ritengo che il successo – nelle sue dimensioni, poi - abbia sorpreso egli stesso e il suo intero entourage. Quanto gli alleati. Erano pronti a celebrare una dignitosa resa, si ritrovano con in mano il tesoro di un quinquennio de gestire e soprattutto con un progetto sul quale coinvolgere il resto della compagnia romana: rimettiamoci insieme, che uniti si vince. I fatti ci diranno quale sarà l’esito dell’uno e dell’altro compito ai quali il centrodestra si accinge.
Di sicuro non può chiamarsi fuori, il duopolio Forza Italia-Lega, con annessi alleati, dal disastro dell’astensionismo che ha tenuto lontani dai seggi la metà dei liguri. Un esercito di elettori che ritiene poco credibile l’opposizione regionale dell’ultimo decennio almeno quanto ha giudicato inaffidabili i partiti e i loro rappresentanti che nello stesso periodo hanno amministrato la regione (fra i trombati eccellenti tre assessori uscenti come Enrico Vesco, Lorena Rambaudi e Matteo Rossi).
E qui veniamo a Paita e al Pd. Con una osservazione in premessa: il voto boccia in modo inequivoco e (probabilmente) definitivo il “burlandismo”, cioè il sistema di potere che il governatore uscente Claudio Burlando aveva messo in piedi tessendo la sua tela prim’ancora di arrivare alla presidenza della Regione.
A ben vedere, anzi, Burlando ha perso due volte: perché ha visto crollare il suo gigante dai piedi d’argilla (indebolito dal groviglio di interessi, conflitti di interesse e giochi delle tre carte in ogni luogo che contasse) e perché ha mandato al massacro la “delfina”, che aveva designato come se l’ente regionale fosse diventato un qualsiasi regno di marzapane da tramandare per via ereditaria. A costo di apparire maramaldo, non posso dimenticare quando Burlando, rivolto a Primocanale, colpevole di ammonire che il Pd era su una brutta china, formulò questa folgorante predizione: “Farete una brutta fine”. Ora deve spiegare le ragioni di una Caporetto. Ognuno ha la fine che si merita.
Alla regola non sfugge Raffaella Paita, che forse tradita da una pur legittima ambizione ci ha messo del suo: accettando il “lascito” di Burlando (solo adesso sussurra: magari dovevo smarcarmi di più) e dallo stesso facendosi guidare verso alcune scelte scellerate. Fra le più gravi, quella di esportare sul meccanismo delle primarie la logica delle larghissime intese, traducibile in grande inciucio, che ha contrassegnato la stagione burlandiana. Lella ha raccattato di tutto, lungo il percorso delle primarie (persino Vesco, poi, s’inalberò: “Con certa gente io non mi candido”), e più s’affannava a rivendicare le proprie origini nel Pci, come se ciò dovesse darle una patente di impunità, più perdeva di vista quanto quel suo pur giovane passato stridesse con la realtà dei suoi comportamenti.
Se, però, il Pd – a Genova come a Roma – cadesse nella tentazione di scaricare il peso della sconfitta tutto su Paita, commetterebbe un nuovo, imperdonabile errore. Di ingenerosità, perché la donna si è battuta leoninamente e merita comunque l’onore delle armi, e di ingiustificato strabismo autoassolutorio. Ci sono stati mille e uno momenti nei quali i vertici del partito ligure avrebbero dovuto gestire la situazione mostrando attributi che evidentemente non ci sono. Quando Giovanni Lunardon e Alessandro Terrile sono andati a Roma per spiegare a Renzi quanto la situazione si fosse complicata, sono stati respinti con perdite. Preceduti dai contatti di Burlando? Non lo so. Probabile, possibile. Ma a quel punto, dirigenti che si rispettino avrebbero messo il leader di fronte al fatto compiuto: “Non credi alle nostre parole? Bene, qui ci sono le nostre dimissioni”.
Dimissioni è una parola che alle latitudini italiche sembra consegnata alle voci arcaiche, buona solo per il vocabolario. Lunardon e Terrile non la pronunciano neppure nella notte della disfatta, come primaria e dovuta reazione istintiva. Finalmente risuona nel day after, in tutta evidenza tardiva. Prima, invece, entrambi – e con loro molti altri big del partito - hanno praticato il tatticismo più deteriore: ci si perdono le partite di calcio, figurarsi le sfide politiche. Incontri a non finire, toppe peggio dei buchi, e poi quell’adagio da Repubblica delle Banane: “Lella vincerà, ma la condizioneremo noi, non Burlando”. Altri, a proposito di tatticismo, invece scelgono la strada del voto disgiunto. Avete presente che cosa succede a lanciare delle uova contro un muro? Appunto.
Ora, eccoli tutti qui, da Paita in giù e in su, a recriminare contro “la sinistra masochista” di Sergio Cofferati (la cui uscita dal partito venne liquidata con un’alzata di spalle) e quindi di Pastorino e Civati, colpevoli di “aver consegnato la Liguria a Berlusconi”. Con il buon peso di prendersela pure con il sindaco di Genova Marco Doria. La sua responsabilità? “Aver spianato la strada alla Lega per quella storia del mercatino abusivo di via Turati”. Deliri da ripicche infantili. L’autocritica resta ai margini, affidata al più classico bla bla: “Certo, ci sono responsabilità di tutti”. Chi, come, perché? Un mistero.
I cattivi maestri, del resto, stanno sulla tolda di comando romana, se Debora Serracchiani, potente numero due pidino, ripete ancora il refrain anti-sinistra. Il copyright, in realtà, è del capo in persona, Matteo Renzi. Che, però, l’odore di zolfo doveva averlo avvertito se alla vigilia del voto ha disertato Genova e se n’è uscito così: “Anche vincere 4-3 va bene”. Nei tre ci stava la traballante Liguria. Invece è finita 5-2, ma la Liguria è volata via lo stesso. Come il Veneto a trazione leghista. Solo che là Salvini la sua scissione – Tosi versus Zaia - l’ha subita e sconfitta. Mentre all’ombra della Lanterna Renzi l’ha subita e basta. Dov’è l’errore?
 7° C
7° C LIVE
LIVE

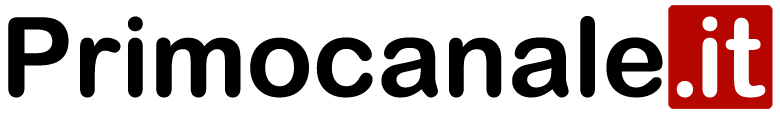
IL COMMENTO
-
Franco Manzitti
Sabato 03 Gennaio 2026
-
La redazione
Venerdì 02 Gennaio 2026
leggi tutti i commentiLa vera sorpresa del 2025, l'idillio Bucci-Salis
Al 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè