E' morto a Roma Sinisa Mihajlovic. Aveva 53 anni e dal 2019 combatteva con la leucemia. Ha giocato nella Sampdoria dal 1994 al 1998 e l'ha allenata dal 2013 al 2015. Esordì nella Stella Rossa. Ha vestito anche le maglie di Roma, Lazio, Inter, da tecnico ha guidato Bologna, Catania, Fiorentina, Milan, Torino e Sporting Lisbona, oltre alla Nazionale di Serbia.
Nemmeno Sinisa ce l’ha fatta, contro l’unico nemico invincibile, lui che aveva vissuto la guerra vera nella sua terra e perfino nella sua famiglia. Ha deposto le armi in silenzio, di fronte al mistero, ci lascia percossi e attoniti. Abbiamo sperato fino all’ultimo che la sua forza indomabile prevalesse sulla malattia. E adesso lo salutiamo in piedi, sull’attenti, come si conviene per un uomo d’arme. Nessuno più di lui era un guerriero, amico mai reticente di guerrieri, aduso a vivere il calcio come prolungamento della guerra con altri mezzi, figlio perfetto di quella Jugoslavia che solo gli jugoslavi possono comprendere. Perché la guerra fa male anche se è bella, è una cosa terribile ma purtroppo è la colonna sonora della storia, ci accompagnerà per sempre, opprime a turno le vite di tutti e negarla o rimuoverla è da bambini, affrontarla invece è appunto da uomini. Mihajlovic è stato un uomo fiero e forte: anche nel momento più difficile, quello della debolezza del male, non ha mai voluto essere compatito.

Figlio di un serbo e di una croata, allo scoppio della guerra balcanica era stato avvisato dallo zio: vattene da casa o ti devo ammazzare. Quando in tempo di pace tornò a Vukovar, non trovò la sua casa e nemmeno la zona dove sorgeva: le bombe avevano stravolto tutto, perfino il paesaggio. “C’era una volta la Jugoslavia”, così comincia quello che fu definito “L’Iliade del Novecento”, il film “Underground” di Emir Kusturica, serbo di Bosnia e amico di Sinisa come Goran Bregovic, bosniaco e basta, autore della musica e presente, con il suo complesso di ottoni balcanici, al matrimonio romano del calciatore.
Lo conoscemmo, appunto, in un giorno di battaglia, il primo di aprile di trent’anni fa, a Sofia, in uno stadio militarizzato affondato in un parco buio, coi tiratori scelti dell’esercito bulgaro sugli alberi. Si presentò all’inizio della più grande partita della storia della Sampdoria, contro la Stella Rossa campione d’Europa e del mondo in carica. Pochi minuti e una sua punizione mise il pallone nel sette di Pagliuca e il campo in salita per i ragazzi con lo scudetto sul cuore, poi stravincenti nel segno dei “gemelli”, anche se il primo gol era stato di Katanec, jugoslavo come lui, però sloveno.
Quel mancino piaceva molto al connazionale Boskov, che pochi mesi dopo se lo sarebbe portato alla Roma e che lo avrebbe allenato a Genova per pochi mesi, tra il '97 e il '98. Sinisa aveva il Doria nel destino e lo raggiunse nel ’94, su chiamata di Eriksson che lo avrebbe trasformato, non senza ironia, in un difensore centrale. Insieme sfiorarono quella che sarebbe stata la seconda Coppa delle Coppe, nell’ultima coda della Bella Stagione che andava disfacendosi. Poi seguì l’amico Mancini alla Lazio e ne divenne l’ombra, in campo e poi in panchina.
Se n’era andato dal Doria in un momento difficile e quando tornò, nell’autunno di nove anni fa in un tempo ancor più complicato, ammise di dover pagare un debito. Risollevò una squadra inanimata, la trasse dal fondo della classifica, rimise “la chiesa al centro del villaggio” aggiudicandosi il derby di ritorno. Non disdegnava la rudezza: segò per sempre Petagna per un pallone perduto in attacco, alzò quasi da terra Regini a fine gara per un fallo inutile nel recupero di un derby.
Ma compì la missione che gli era stata affidata. E in primavera tornò in Serbia per salutare l’altro padre perduto, proprio Boskov giunto alla fine del suo lungo addio a se stesso, sulla collina brulla di Begec, tra i canti di Natale strani a maggio, ma piacevano allo Zio. L’anno seguente Sinisa aspettò la chiamata della Juventus che non sarebbe arrivata mai, si trovò un presidente diverso, assai diverso, da quello con cui aveva concordato il rinnovo. Portò comunque la squadra, la primavera successiva, a quella che a tutt’oggi è l’ultima presenza in Europa. Poi se ne andò, chiamato dal Milan. Poi allenò Torino, Sporting e per tre anni il Bologna, da cui era stato esonerato a settembre. Dal luglio del 2019 era in cura per una leucemia, da lui stesso annunciata in conferenza stampa. Aveva sempre guidato la squadra anche durante le terapie, grazie al suo staff. Ma il tempo, anche il recupero, è scaduto.
Che cosa resta di un uomo? Il tempo pialla e cancella tutto e tutti, la memoria si sfolla. Mihajlovic lascia il vigore della sua stretta di mano, la fessura di un sorriso venato di tristezza, gli occhi fiammanti anche nel tempo dell’estremo conflitto. Quelli gli sono rimasti fino all’ultimo.
“C’era una volta la Jugoslavia”. Già, anche la vita di Sinisa è stata un film. In quello di Kusturica, a un certo punto, si affaccia la voce di Cesaria Evora da Capo Verde, che canta dell’assenza, e del sole tutto solo nel cielo, che brilla cieco nella sua luce senza sapere chi rischiarare, né dove andare. Il film finisce con un banchetto di nozze, su un lembo di riva, che si stacca da terra e comincia a navigare chissà verso dove. Se ne va adesso Sinisa, nel mare senza sponde di tutti e di nessuno. Resta l’ombra di un uomo che ci ha regalato sui campi di calcio qualche fugace folata di felicità, e non è poco.
Alla famiglia le condoglianze della redazione sportiva di Primocanale, onorata di averlo avuto come interlocutore e amico.
 8° C
8° C LIVE
LIVE







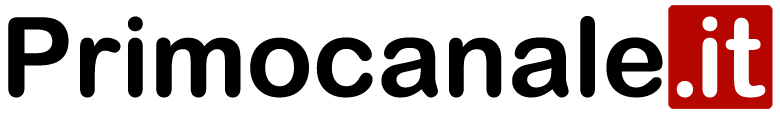
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 22 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 21 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiBimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria