Alla fine degli anni 60 a Roma si celebrò un processo che fece scalpore nel quale il drammaturgo, poeta e studioso delle formiche Aldo Braibanti, marxista e gay, venne condannato a nove anni di carcere con l’accusa di plagio, di aver cioè sottomesso alla propria volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, affinché potesse guarire, si fa per dire, da quello che veniva definito “un influsso diabolico”. E anche se dopo l’appello la condanna fu ridotta a due anni quel processo venne intentato sostanzialmente per mettere sotto accusa i “diversi” di ogni genere e i fuorilegge dalla norma. In particolare, Braibanti è stata l'unica persona condannata per plagio in Italia, reato che verrà poi cancellato dal codice penale per la sua intrinseca vaghezza nel 1981.
Ne ‘Il signore delle formiche’, presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, Gianni Amelio – che in tempi recenti ha fatto outing sulla sua omosessualità - prendendo spunto da uno dei capitoli più neri della storia giuridica italiana del dopoguerra racconta una vicenda a più voci, dove accanto all’imputato prendono corpo i familiari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori e un’opinione pubblica per lo più distratta o indifferente nella quale soltanto un giornalista si impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.
In una nazione come l'Italia che non è tipicamente associata a visioni e atteggiamenti progressisti riguardo alla sessualità, Amelio confeziona un film sulla violenza e l’ottusità della discriminazione, sull’amore sottomesso al conformismo e alla malafede. Uno spaccato della provincia italiana degli anni 60 quando il benessere economico non andò di pari passo con l’apertura dei sentimenti e la famiglia era un luogo chiuso nella quale i contrasti tra le generazioni restavano accesi e conflittuali.

Il signore delle formiche è certamente in linea con quelli che sono i consueti interessi del regista di esplorare le tribolazioni dei diseredati ma tutto questo viene immerso in un melodramma esasperato e il film salta continuamente avanti e indietro nel tempo senza un motivo particolare se non per cercare, magari, di liberarsi dalla logica ineludibile della storia o dalla specificità dell’epoca e del luogo dando la sensazione di un esercizio di stile che affronta con troppa leggerezza i vari elementi che contiene, dal romanzo tragico allo spaccato politico dell'epoca fino allo scontro nell’aula del tribunale.
Tuttavia, anche se in apparenza oggi non ci si scandalizza più di niente, l’odissea raccontata è di quelle che non lasciano indifferenti perché sanno d’inquisizione, e ne abbiamo le prove ogni giorno dal momento che nella sostanza non è cambiato molto: dietro una facciata permissiva, i pregiudizi esistono e resistono ancora, generando odio e disprezzo per ogni “irregolare”. Così, al di là dell’appassionata esposizione di un’ingiustizia storica, è importante per il monito che contiene nei confronti di un'Italia contemporanea in cui le forze di reazione sono di nuovo in movimento.
Il film di Amelio vuole infondere il coraggio di ribellarsi a questa logica perché – sottende - non è più tempo di subire né di tollerare qualunque forma di sopruso verso gli individui meno protetti. E se durante tutta la storia si è cercato di evitare le corde del sentimento, della poesia e del romanticismo, queste emergono con forza alla fine, nell'ultima scena d'addio tra i due protagonisti, ambientata su un'aria dell’Aida cantata da Renata Tebaldi, quando il fragile ecosistema che sosteneva il loro amore è definitivamente crollato. Con rabbia e rimpianto, sentimenti che Amelio, in quanto omosessuale sopravvissuto a quell’era repressiva, evidentemente ricorda fin troppo bene.
 9° C
9° C LIVE
LIVE





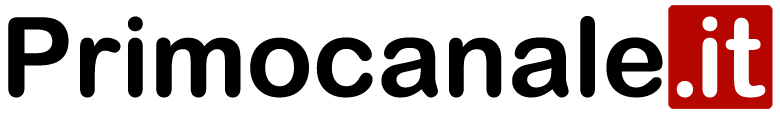
IL COMMENTO
-
Mario Paternostro
Domenica 14 Dicembre 2025
-
Franco Manzitti
Sabato 13 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiA Livellato il presepio-flash col bue che trascina la capanna
Lo sprint di Andrea Orlando ex perdente lanciato verso dove?