
Perchè la prematura e ingiusta morte di Gianluca Vialli, il campione, l'uomo, il “ragazzo italiano” di tanti successi e simpatia e fraternità e amicizia e rispetto, ha provocato tanta partecipazione?
Perchè gli stessi giornalisti, conduttori televisivi, amici vicini, ma anche lontani e anche tanti indifferenti al calcio, alle sue epopee, di cui era un eroe, in una così strana festività dell'Epifania, travolta dal suo lutto, annunciato sì ma così vissuto ovunque, si sono commossi in modo visibile?
Perchè la sua morte a 58 anni, dopo una vita certo fortunata per il suo trionfo sportivo, per il suo talento umano, per la capacità carismatica di comunicare con tutti, di essere diretto e chiaro e generoso e di trovare sempre le parole giuste, il tono giusto, la misura perfetta dei gesti, degli atteggiamenti, ma arrivata così presto, viene pianta tanto universalmente?
Nella settimana, nei giorni, davvero strani nei quali altre morti “eccellenti” hanno mosso i sentimenti di questa umanità che ha imparato da qualche anno a confrontarsi in un altro modo con la fine della vita, la pandemia da decine di milioni di morti, la guerra che non si ferma, la fine di un papa emerito vestito di bianco, la salma esposta al mondo in quel modo antico e forte, il campione di calcio universale come Pelè in un altro angolo del mondo, l'amico, Sinisa, altro eroe del calcio...
Credo che una possibile spiegazione ci sia, almeno la mia, dal centro di questa città così coinvolta per l'addio di quel ragazzo dai riccioli neri arrivato qua quasi bambino e diventato Vialli, anzi super Vialli, “ciao Gianluca”, come giustamente ha scritto la Regione sul suo muro diventato il tamburo della nostra comunicazione.
Vialli ha detto della sua malattia quello che nessuno ha il coraggio di dire, l'ha affrontata a viso aperto, ma l'ha anche ripetuto, ha comunicato quello che pensava, ha inventato frasi e definizioni fino a allora inconsuete. L'”ospite indesiderato” salito con lui sul treno, impossibile da battere, la convinzione di doverci convivere, il desiderio di vivere ancora per fare tante cose, morire dopo i suoi genitori, portare all'altare le sue ragazze e chissà che altro, certamente salvare la Sampdoria, il sogno di lui ragazzo e di Mancini, suo fratello, e degli altri amici di quell'avventura indimenticabile, come chiudere un cerchio felice.
Non si poteva fare. E lui l'ha spiegato, passaggio dopo passaggio, mentre continuava a vivere la sua vita di eroe invincibile, con la maschera della sofferenza palese, ma prescindibile dal resto.
La vittoria agli Europei, quell'abbraccio con il Mancio, quel messaggio di Roosvelt letto ai giocatori prima della finale, quei rigori visti di spalle.
Era lui, quello delle acrobazie mirabolanti in campo, delle coppe sollevate, dell'invincibilità sportiva e empatica, ma anche della sofferenza sempre più evidente, dell'affilamento del suo corpo così atletico un tempo, nascosto con i maglioni, come raccontava, lui perfezionista di tutto, anche nel dare un messaggio giusto che aiuterà tanti.
E fosse solo uno a coglierlo avrebbe vinto ancora, alzato un'altra coppa che ha sempre lo stesso segno, quello della generosità assoluta, del dare il meglio di se stesso agli altri. Che è il miglior modo di entrare nella luce del dopo, che aspettava e che è arrivata anche se troppo presto.
Questa è la mia ragione di questa emozione collettiva, da genovese, per di più genoano. Ce ne sono tante altre e forse la mia è solo emotiva, come è giusto che sia oggi. Grazie Gianluca.
 9° C
9° C LIVE
LIVE






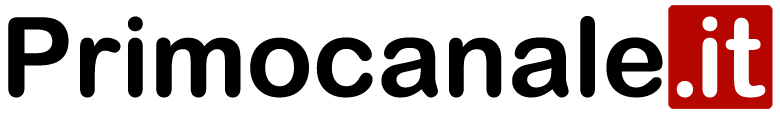
IL COMMENTO
-
Matteo Angeli
Giovedì 25 Dicembre 2025
-
Luigi Leone
Lunedì 22 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiIl Natale della comunità: l'impegno di Primocanale e gli auguri della redazione
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie