Un uomo trascinato via dalla piena, centinaia di case distrutte, interi quartieri sommersi dal fango. Tra il 9 e il 10 ottobre 2014, Genova visse una notte drammatica. In poche ore caddero quasi 400 millimetri di pioggia, trasformando torrenti e strade in un’unica colata d’acqua che devastò la città.
Il torrente Bisagno esondò intorno alle 23:30, invadendo il cuore di Genova, da Brignole alla Foce. Nel tunnel tra via Canevari e la stazione venne trovato senza vita Antonio Campanella, infermiere di 57 anni, travolto mentre cercava di mettersi in salvo. L’acqua trascinò via auto, negozi e vite, lasciando dietro di sé un paesaggio spettrale di fango e macerie.
Un territorio fragile
Le cause furono molteplici: la combinazione di correnti umide e calde da sud con aria fredda settentrionale generò un sistema temporalesco stazionario che scaricò sulla città un’enorme quantità di pioggia. Ma il disastro fu amplificato da decenni di urbanizzazione disordinata e da tombinature di corsi d’acqua che ridussero drasticamente la capacità di deflusso.
Il bacino del Bisagno, già al centro di altre tragedie, confermò la propria pericolosità. Genova, stretta tra il mare e i rilievi, è da sempre vulnerabile a fenomeni di questo tipo, e la conformazione del territorio – un dedalo di torrenti, strade e costruzioni ravvicinate – rende complessa qualsiasi difesa strutturale. Questa tragedia, unita alle altre, ha accelerato le opere idrauliche, gli scolmatori del Fereggiano (già entrato in funzione) e del Bisagno (in corso d’opera).
CLICCA QUI PER NAVIGARE NELL'ARCHIVIO STORICO DI PRIMOCANALE

Una città sott’acqua
La furia dell’acqua colpì con violenza il cuore cittadino. Borgo Incrociati, via XX Settembre, piazza della Vittoria e numerose vie del centro vennero invase dal fango. Auto accatastate, vetrine distrutte, scantinati allagati. Nei quartieri della Val Bisagno i residenti ricordano il rumore incessante dell’acqua, l’odore acre del fango, il buio improvviso per i blackout elettrici. “Stanotte ho perso tutto”, disse un uomo guardando la propria bottega devastata.
A Cornigliano, tre operai rimasero intrappolati in un capannone, circondati dall’acqua fino al petto, e furono tratti in salvo solo grazie all’intervento di passanti. Nel centro storico l’acqua entrava dalle porte e scendeva nei vicoli come una cascata. “È stato peggio del 2011”, ricordano ancora molti genovesi che avevano già vissuto l’alluvione di tre anni prima.
I danni e la solidarietà
Il bilancio fu pesante: 250 milioni di euro di danni, centinaia di attività distrutte, decine di comuni coinvolti nella Città Metropolitana. Le ferrovie subirono guasti e interruzioni, l’autostrada A12 venne chiusa in diversi tratti, e molte scuole restarono inagibili per giorni.
Ma accanto alla distruzione emerse la reazione straordinaria dei cittadini. Migliaia di volontari, quelli che a Genova sono chiamati “angeli del fango”, si riversarono per le strade con pale e secchi, spalando giorno e notte per liberare la città. Giovani, famiglie, perfino commercianti danneggiati che, invece di arrendersi, aiutarono gli altri a ripartire. Un moto di solidarietà che rimane una delle pagine più commoventi della storia recente di Genova.
Le responsabilità e le domande aperte
Nei mesi successivi furono aperte inchieste per disastro e omicidio colposo, con l’obiettivo di verificare eventuali omissioni nei sistemi di allerta e di manutenzione. Molte critiche si concentrarono sull’assenza di un’allerta adeguata e sulla lentezza dei lavori di messa in sicurezza del Bisagno.
Da allora sono stati avviati interventi strutturali, tra cui il progetto di copertura e scolmatore del Bisagno, ma il ricordo di quella notte resta vivo. Ogni autunno, quando tornano le prime piogge, Genova si interroga sulla propria sicurezza e sulla capacità di convivere con una fragilità idrogeologica che è parte della sua stessa geografia.
 8° C
8° C LIVE
LIVE


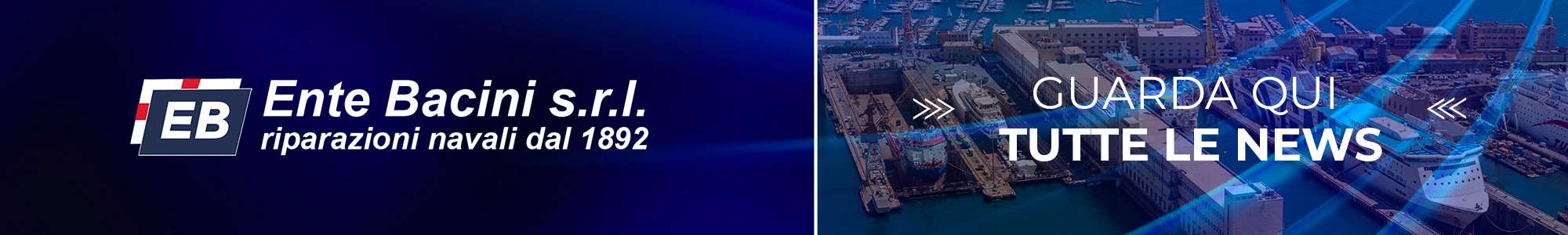


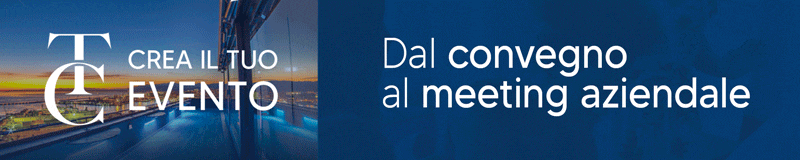
IL COMMENTO
-
Sara Piattino*
Mercoledì 07 Gennaio 2026
-
Luigi Leone
Lunedì 05 Gennaio 2026
leggi tutti i commentiCrans Montana: perché restiamo a guardare? 8 chiavi per capire la psicologia nel cuore della tragedia
Il Casinò di Sanremo, un patrimonio non sfruttato da tutta la Liguria