Nel 2016, nell'aula di tribunale di Saint-Omer, cittadina tra Calais e Lille, si svolse un processo a carico di una giovane franco-senegalese accusata di aver ucciso il suo bambino: un gesto così assolutamente antitetico alle idee accettate di maternità e femminilità da essere considerato “il peggiore di tutti i crimini possibili”. La donna, studentessa con un quoziente intellettivo sorprendentemente alto, confessò l’omicidio ma affermando nello stesso tempo di essere stata vittima di un atto di stregoneria.
E' intorno a questa vicenda che la documentarista Alice Diop ha girato il suo primo film di fiction, 'Saint Omer' con cui ha vinto il Gran premio della giuria alla recente Mostra di Venezia, dove immagina che un'accademica incinta decide di seguire il caso giudiziario come parte integrante di una ricerca per un saggio che sta scrivendo sulla più famosa infanticida della storia: Medea. Ma nonostante l'interesse inizialmente sia solo professionale, il semplice atto di frequentare il processo le fa trovare forti parallelismi tra la storia di quella donna e se stessa.
Approfondendo gli eventi, i traumi dell'imputata tornano in superficie. In particolare il rapporto travagliato con la propria madre e il fatto di essere stata respinta dai suoi genitori, dalla società e dal proprio marito. Avendo vissuto in maniera invisibile, come non fosse mai esistita, questo personaggio che si rivela sempre più affascinante mano a mano che il film va avanti dimostra come l'indifferenza da parte di chi ci ha generato, un razzismo profondamente radicato e il trauma generazionale che ereditiamo dai nostri genitori plasmino irrevocabilmente chi siamo. Ed evolvendosi da assassina apparentemente senza cuore in essere umano profondamente ferito lo spettatore finisce per chiedersi se sia una vittima, un colpevole, o forse l'uno e l'altro.

'Saint Omer' è tante cose insieme: un saggio su relazioni familiari alienate e reciprocamente incomprensibili, uno studio sulla natura della maternità, la sua complessità e l'impatto traumatico che a volte può avere, un ritratto sommesso ma intrigante di una madre apparentemente mostruosa e della donna che lotta per capirla, una storia di connessioni umane. Un film inquietante e sorprendente che non dà risposte perché l'intento della regista è proprio quello di non cercarle ma piuttosto scavare in profondità nelle nostre anime, ponendoci domande cruciali sulla genitorialità, sul trauma generazionale e su come le ferite inespresse del passato possono avere un effetto duraturo sulle nostre decisioni future. Un dramma giudiziario che diventa intenzionalmente claustrofobico e provocatorio come quando nel finale l'avvocato difensore sostiene che le donne sono mostri umani, che portano il Dna di chi le ha generate così come quello dei figli, che trattengono all'interno gli orrori e le paure indicibili delle proprie madri mentre viene chiesto loro di prendersi cura delle nuove creature che hanno concepito.
Guardando lo spettatore attraverso gli occhi di questa Medea senegalese che era sola perché nessuno voleva vederla Alice Diop non fa prigionieri: ti mette a disagio, ti incuriosisce, ti disturba. Ma sono proprio questi i tratti distintivi di un cinema umanista e politico allo stesso tempo che ci aiuta a riscoprire noi stessi e il nostro posto nel mondo per poter meglio comprendere coloro che ci circondano e vederli per quello che sono realmente.
 9° C
9° C LIVE
LIVE





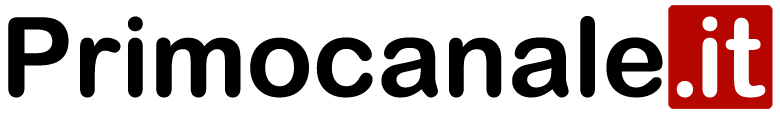
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 22 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 21 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiBimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria