
7 marzo 1985. Esce We Are the World. Con oltre 20 milioni di copie vendute sarà l’ottavo disco a 45 giri di maggior successo di sempre. È però un disco un po’ speciale. Per gli scopi che persegue, gli autori ed esecutori, le modalità di registrazione. È un’iniziativa benefica: obiettivo, raccogliere fondi contro la terribile carestia in corso in Etiopia, che fra il 1983 e l’85 lascia sul campo oltre un milione di vittime. In tempi di “edonismo reaganiano” rampante, ci vuole un veterano della sinistra del mondo dello spettacolo statunitense come il quasi sessantenne Harry Belafonte, ex re del calipso e figura di punta del movimento per i diritti civili, per farsi venire l’idea di imitare quello che ha appena fatto un mese prima un gruppo di cantanti e gruppi britannici.
Capitanati da Bob Geldorf, stelle del pop e rock britannico quali Sting, i Duran Duran, gli Spandau Ballet e Boy George avevano inciso per la stessa causa della carestia etiope il brano Do They Know It’s Christmas. La risposta statunitense fu una conferma della tendenza americana a pensare in grande. Belafonte fu ben lieto di lasciare la luce dei riflettori a divi del momento di maggiore impatto di lui. Contattò il manager dello showbiz Ken Kragen, che a sua volta coinvolse il suo assistito Lionel Richie, fresco di una lunga sfilza di successi, in una generosa catena di sant’Antonio che presto comprese anche il produttore Quincy Jones, che a sua volta chiamò Michael Jackson. Jackson scrisse We Are the World, un inno alla solidarietà e all’umanitarismo internazionale, con Richie. Registrato il 28 gennaio 1985, il brano raccolse 45 fra i più grandi artisti musicali americani di sempre, con una significativa presenza di afroamericani. Oltre a Jackson, Richie e Jones, Bob Dylan, Diana Ross, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Ray Charles, Tina Turner, Willie Nelson, Kenny Rogers, Billy Joel, Stevie Wonder, Steve Perry e Paul Simon.
Ma non mancarono le critiche. Il noto critico musicale Greil Marcus disse che gli sembrava un “jjngle della Pepsi”, il musicologo universitario Reebee Garofalo lo accusò di “auto-indulgenza”, lo storico Kevin Mattson vi ha visto una “performance narcisistica”. Di opinione diametralmente opposta, a caldo, il non meno noto critico musicale Robert Christgau, e più recentemente Time e Washington Post, che, un anno fa, all’uscita del documentario Netflix sulla realizzazione del disco, hanno esaltato il progetto, sottolineando come “per un breve momento musicale, siamo stati il mondo”.
Ferdinando Fasce, già professore ordinario di Storia Contemporanea nell’Università di Genova
 8° C
8° C LIVE
LIVE



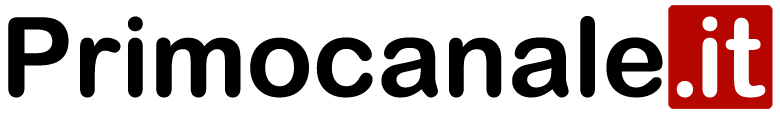
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 15 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 14 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiGenova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi
A Livellato il presepio-flash col bue che trascina la capanna