 Se usassimo le categorie della storia, meglio, della preistoria, dovremmo definire quella attuale l'età dell'acciaio. Che politicamente si traduce, si dovrebbe tradurre, in forza, prima di tutto economica. Le cose stanno un po' diversamente e l'ennesimo allarme lanciato dalla Cina sulla sua sovrapproduzione siderurgica è lì a testimoniarlo.
Se usassimo le categorie della storia, meglio, della preistoria, dovremmo definire quella attuale l'età dell'acciaio. Che politicamente si traduce, si dovrebbe tradurre, in forza, prima di tutto economica. Le cose stanno un po' diversamente e l'ennesimo allarme lanciato dalla Cina sulla sua sovrapproduzione siderurgica è lì a testimoniarlo.Già lo scorso anno Pechino ha visto una contrazione del 2,3 per cento e ora il governo pianifica una diminuzione di 150 milioni di tonnellate entro il 2020. Il Paese fornisce grosso modo il 50 per cento di acciaio a livello globale e il fatto che abbia i magazzini pieni di invenduto ratifica le difficoltà di crescita economica certificate da tutti gli indicatori, a cominciare da quello relativo al Pil.
Questo è l'effetto collaterale della crisi globale, le cui origini finanziarie si sono poi inevitabilmente trasferite sull'economia reale. La sovrapproduzione di acciaio non è un'emergenza solo dell'oggi, posto che altre fasi, negli ultimi trent'anni, hanno registrato lo stesso fenomeno. La differenza è che l'ultimo ciclo recessivo si sta dimostrando un osso più duro da rodere rispetto al passato.
La situazione cinese provoca sul mercato internazionale anche il cosiddetto effetto dumping, cioè un'invasione dei lavorati cinesi a prezzi insostenibili per la concorrenza, che seguono regole, per cominciare quelle del lavoro, al momento sconosciute alle latitudini di Pechino. E le conseguenze in Occidente si sono già viste, con molti gruppi messi quasi in ginocchio.
Nonostante la situazione, e un calo dell'1,7 per cento dell'utilizzo di acciaio a livello globale nel 2015, ancora lo scorso ottobre la World Steel Association (Wsa) stimava che il prossimo anno la produzione supererà i 2,4 miliardi di tonnellate, sebbene nel 2016 le vendite siano valutate in aumento non più dello 0,6 per cento.
Ovviamente anche l'Italia si inserisce in questo scenario, con la complicazione di avere il proprio campione nazionale, l'Ilva, ridotto al lumicino e in vendita (o in affitto, in via transitoria). E la sovrapproduzione mondiale di acciaio inevitabilmente impatterà sul processo di cessione del colosso con sede a Taranto e propaggini importanti a Genova e Novi Ligure.
Nella migliore delle ipotesi, chi comprerà (in gara si presentata anche la cinese P&C) varerà un piano industriale che si adatti al contesto congiunturale poco favorevole, quindi con una prevedibile riduzione sia della produzione sia, di conseguenza, del numero di lavoratori occupati. Già questa promette di essere una soluzione "lacrime e sangue". Ma non è neppure la peggiore. A seconda di chi ci metterà le mani sopra, infatti, l'Ilva corre anche il serio pericolo di essere rasa al suolo, secondo una dinamica tipica di certe multinazionali, che comprano un concorrente e poi lo eliminano, per liberare il loro stesso mercato da una presenza ingombrante.
Per l'Italia l'uscita dalla siderurgia, a parte qualche presidio minore, sarebbe una botta tremenda, sia in termini di immagine sia dal punto di vista dell'economia reale. Questo giustifica la prudenza con cui si sta muovendo il governo e anche l'idea di mettere in campo una cordata nazionale che, con l'ausilio di Cassa Depositi, mantenga almeno la maggioranza azionaria di Ilva. Per ora, tuttavia, è discutibile il modo seguito, pur dovendo riconoscere le difficoltà che derivano dalla posizione dell'Ue, contraria a qualsivoglia intervento finanziario diretto (per l'unico realizzato ci toccherà una procedura di infrazione).
È una linea che finisce per tutelare gli altri Stati membri dell'Unione, che a partire dalla Germania si sono risolti i problemi di casa per tempo, a totale discapito del nostro Paese, che invece ha fatto a lungo il pesce in barile con la sua emergenza principale. Arrivando all'assurdo, quando ormai la crisi dell'Ilva era conclamata, di approvare il provvedimento con cui Bruxelles ha tolto la siderurgia dai settori di "interesse strategico nazionale", sui quali un governo poteva far scattare clausole di salvaguardia senza incappare nella tagliola degli aiuti di Stato.
Tuttavia, l'annuncio cinese sul taglio alla produzione di acciaio e la chiusura ai permessi per aprire nuovi impianti potrebbe essere anche una buona notizia, pensando all'ecosistema globale e posto che le acciaierie, fra i principali emittenti di anidride carbonica, sono fra le cause maggiori del cosiddetto effetto serra.
Non si può ignorare, però, che riguardo all'argomento la scelta della Cina è ancor meno di un brodino. Ci vorrebbe ben altro, come osservano da anni gli scienziati, per fermare e almeno stabilizzare, prima di farle decrescere, le emissioni di Co2. Del resto, al di là della contingenza economica, a gelare ogni illusione è proprio il dato della Wsa: nonostante la domanda in ribasso, la produzione di acciaio continuerà nel suo insieme a crescere. Alla faccia della salute del pianeta. E, forse, con la nostra Ilva fuori dai giochi.
 12° C
12° C LIVE
LIVE

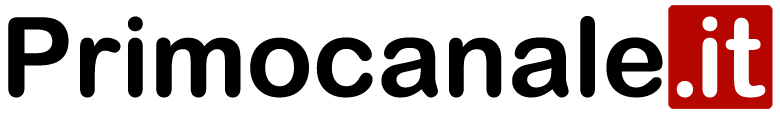
IL COMMENTO
-
Luigi Leone
Lunedì 22 Dicembre 2025
-
Mario Paternostro
Domenica 21 Dicembre 2025
leggi tutti i commentiBimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria