 Goffredo Mameli sale dalla sua casa di piazza San Bernardo sulla collina di Oregina: è il 10 dicembre del 1847 e nella chiesa che domina la città non c’é un posto libero. Si celebra come tutti gli anni la rivolta del 1746 contro gli austriaci. Quella di Balilla. Ma oggi tira un’aria diversa, più frizzante. Trentacinquemila genovesi sono partiti dall’Acquasola per raggiungere con un imponente pellegrinaggio, il santuario di Nostra Signora di Loreto. E’ la festa dello Scioglimento del voto. Goffredo ha vent’anni e da poche settimane ha scritto il testo del “Canto degli Italiani” musicato da Michele Novaro. “Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa….” Comincia così. Cantano tutti accompagnati dalla Filarmonica di Sestri Ponente, la celebre banda “Casimiro Corradi”. Sventolano il tricolore. Chiedono che il re Carlo Alberto dichiari guerra all’Austria. Nella notte vengono accesi i falò sulle colline.
Goffredo Mameli sale dalla sua casa di piazza San Bernardo sulla collina di Oregina: è il 10 dicembre del 1847 e nella chiesa che domina la città non c’é un posto libero. Si celebra come tutti gli anni la rivolta del 1746 contro gli austriaci. Quella di Balilla. Ma oggi tira un’aria diversa, più frizzante. Trentacinquemila genovesi sono partiti dall’Acquasola per raggiungere con un imponente pellegrinaggio, il santuario di Nostra Signora di Loreto. E’ la festa dello Scioglimento del voto. Goffredo ha vent’anni e da poche settimane ha scritto il testo del “Canto degli Italiani” musicato da Michele Novaro. “Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa….” Comincia così. Cantano tutti accompagnati dalla Filarmonica di Sestri Ponente, la celebre banda “Casimiro Corradi”. Sventolano il tricolore. Chiedono che il re Carlo Alberto dichiari guerra all’Austria. Nella notte vengono accesi i falò sulle colline.Mameli era, come si dice, figlio di ottima famiglia, Mameli dei Mannelli, padre ammiraglio. Aveva conosciuto Giuseppe Mazzini, poi Nino Bixio e con Garibaldi nel 1849 va a Roma a combattere per la repubblica appena nata. E muore a ventuno anni di infezione, colpito accidentalmente dalla baionetta di un compagno. A ventuno anni. Oregina. Cioè Oh, Regina! L’invocazione scritta su un’ immagine della Madonna dipinta sulla facciata della chiesa. Là, dove la notte tra il 9 e il 10 dicembre 1746 il padre francescano Candido Giusso ha una visione: la Vergine che schiaccia un serpente e santa Caterina Fieschi Adorno, la santa genovesissima, che prega inginocchiata ai suoi piedi. Quel giorno gli austriaci se ne vanno da Genova. Il voto, il miracolo, gli appuntamenti ogni anno.
Oggi, poco sotto Oregina ci sono due strade: si chiamano via Ischia una e l’altra è via Fracchia. Tra la casa dove abita Guido Rossa, magazziniere dell’Italsider, comunista convinto e quella dove sono nascosti quattro giovani brigatisti in assoluta clandestinità, ci sono meno di cento metri. Il 24 gennaio 1979 Guido, che ha da poco denunciato un compagno di lavoro che distribuiva in fabbrica farneticanti volantini delle Brigate rosse che hanno già insanguinato Genova, sta per entrare nella sua vecchia 850. Si accorge di essere seguito. Affretta il passo e entra in auto, ma uno dei due inseguitori gli spara a una gamba. Guido si accascia sul sedile con le mani appoggiate al volante. Tutto finito? No. L’altro terrorista torna indietro, gli punta la pistola alla testa e lo uccide. Non era previsto , ma lo uccide.
Tutto accade a nemmeno cento metri dall’appartamento di via Fracchia, quello col giardinetto sotto il livello della strada. Un anno dopo, alle 4 del mattino del 28 marzo 1980, gli uomini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fanno irruzione nell’appartamento, il covo, e uccidono i quattro terroristi che lo abitano. Un’azione mai chiarita del tutto. Ma segna la fine della spietata colonna genovese delle Br. Quella che, secondo le recentissime rivelazioni della Commissione Moro, avrebbe anche gestito gli ultimi giorni di prigionia del presidente della Democrazia Cristiana, fino alla sua atroce esecuzione. E nel giardinetto che si vede lì sotto sarebbero state sepolte la lettere originali mai trovate, scritte nella prigionia dallo statista. Scomparse. Uno dei tanti misteri degli anni di piombo che a Genova lasciano una fitta e tragica topografia.
Piazzale Adriatico dove stavano i Gap, poi diventati la Banda XXII Ottobre, i cosiddetti tupamaros della Valbisagno raccontati così lucidamente nel libro “Animali di periferia”. La periferia della città che scivola lungo il Bisagno. Stadio e fasce di ginestre, cimitero e ciminiere, trattorie e carceri. Piazzale Adriatico, la piazza alberata sotto il livello del torrentaccio delle terribili alluvioni, fango e poveri morti. La Val Bisagno dove a Borgo Incrociati si incrocia ancora una volta l’antica storia dei ribelli anti-austriaci nel 1746 e quella del terrore degli anni di piombo nel 1978. In un’ osteria vicina al ponte di Sant’Agata stanno bevendo alcuni soldati austriaci. Un ragazzino chiamato Pittamuli entra dentro con una fascina e appicca il fuoco. Spara, ne uccide uno. Scoppia la rivolta. Cacciati gli occupanti.
Entriamo dentro il borgo. All’imbocco dove era l’indimenticabile trattoria Pacetti paradiso per gli studenti di Giurisprudenza, (era gestita affettuosamente dal segretario della facoltà di Giurisprudenza e da sua moglie), c’è una scalinata anonima che sale in corso Montegrappa. Qui fu lasciato il comunicato Br che annunciava la sentenza di condanna a morte di Moro: era il maggio del 1978. Le Br chiamarono il Decimonono. Forse ci andarono Piero Telefono, con Carlo Bancalari o Manlio Di Salvo, tris d’assi della “nera”, a prenderlo nel cestino della spazzatura. Ero al “Secolo XIX” da un mese. Ci gelò il sangue quando lo lessero davanti al direttore Michele Tito e ai maestri dei cronisti Pietrin Ferro e Sergio Paglieri.
Metri di strade e sangue. Scalini, creuse e sangue. Piazze e funerali. Tutte le settimane c’era un “attacco allo Stato imperialista”.
Salita Santa Brigida dove le Br uccidono il procuratore Coco e la sua scorta. Spianata Castelletto dove rapiranno l’armatore Piero Costa, Albaro dove sequestrarono il giudice Mario Sossi e uccisero anni dopo il commissario Esposito, freddandolo sull’autobus della linea 15. E sempre in Albaro l’assassinio in via Riboli del colonnello Tuttobene e dell’appuntato Casu. I carabinieri Battaglini e Tosa uccisi a Sampierdarena. Il rosario dei “gambizzati”, interminabile.
Il fattorino Floris ucciso forse per sbaglio? (ora si parla del rimbalzo di un colpo sparato a terra) in via Bernardo Castello, mentre usciva dalla sede dell’Istituto autonomo delle case popolari. L’omicidio raccontato da quella fotografia dove ci sono una vecchia Lambretta e tre uomini, quello che la guida, quello dietro che si volta e spara e uno a terra morente che tende un braccio per difendere disperatamente la sua borsa di lavoro.
E’ impressionante stendere su un tavolo la cartina di Genova e segnare con una penna i luoghi del terrorismo. Non c’è quartiere della città che resti pulito. Qua e là qualche targa ricorda le povere vittime. Ogni targa è una storia di angoscia, una cruda topografia del dolore. Storia e storie si incagliano, personaggi epici e assassini. La parola libertà, che sventola. A volte giusta e altre, tante, sbagliata. Ma guai a dimenticare. Guai.
(13-continua)
 18° C
18° C LIVE
LIVE









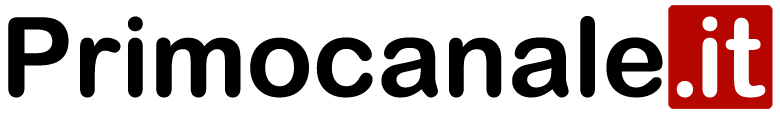
IL COMMENTO
Matteo Cantile Martedì 16 Aprile 2024 Luigi Leone Lunedì 15 Aprile 2024
leggi tutti i commentiDiffamazione, in Italia la libertà di stampa è a rischio
Da Sanremo brutte ventate per la libera informazione