 La sera del 4 novembre 1995, dopo aver preso parte ad un comizio a Tel Aviv, Yitzhak Rabin, primo ministro dello Stato di Israele, che due anni prima ad Oslo aveva trovato con Arafat un faticoso accordo di pace che molti in patria non avevano approvato, fu assassinato da un colono ebreo estremista. A vent’anni di distanza Amos Gitai ricorda quegli eventi in ‘Rabin, the last days’, in concorso (ulteriore testimonianza di quanto questa Mostra abbia deciso di fare i conti con la realtà e – in questo caso – addirittura con la Storia) filmando un’inchiesta tanto dolorosa quanto necessaria e mettendo a nudo come le indagini sul brutale assassinio abbiano rivelato quel mondo oscuro e agghiacciante che rese possibile questo tragico atto.
La sera del 4 novembre 1995, dopo aver preso parte ad un comizio a Tel Aviv, Yitzhak Rabin, primo ministro dello Stato di Israele, che due anni prima ad Oslo aveva trovato con Arafat un faticoso accordo di pace che molti in patria non avevano approvato, fu assassinato da un colono ebreo estremista. A vent’anni di distanza Amos Gitai ricorda quegli eventi in ‘Rabin, the last days’, in concorso (ulteriore testimonianza di quanto questa Mostra abbia deciso di fare i conti con la realtà e – in questo caso – addirittura con la Storia) filmando un’inchiesta tanto dolorosa quanto necessaria e mettendo a nudo come le indagini sul brutale assassinio abbiano rivelato quel mondo oscuro e agghiacciante che rese possibile questo tragico atto.Una sottocultura di odio alimentata da retorica isterica, paranoia e intrighi politici con rabbini estremisti che condannarono Rabin invocando un’oscura sentenza talmudica, eminenti politici di destra che si unirono contro di lui in una campagna di incitamento all’odio, i coloni israeliani militanti per i quali la pace significava tradimento e gli agenti della sicurezza che videro cosa stava per succedere e non riuscirono ad impedirlo. Insomma, la cronaca di una morte annunciata che Gitai decide di raccontare tra immagini di repertorio e fiction, andando avanti e indietro nel tempo e preferendo più che la strada del thriller politico che non è nelle sue corde, quella piuttosto di un ‘court room drama’ nel suo seguire soprattutto i lavori della Shamgar Commission che ebbe il ruolo di investigare l’assassinio di Rabin trovandosi di fronte un continuo palleggiarsi di responsabilità.
Ma tra un interrogatorio e l’altro si insinua il lato debole del film che procede in maniera piuttosto ripetitiva, una continua escussione di testi uno via l’altro evitando di approfondire più di tanto, dall’altro lato, la psicologia dell’omicida. E se pure le due ore e mezza di proiezione non pesano, resta la sensazione che una maggiore asciuttezza avrebbe sicuramente giovato alla pellicola.
La domanda che invece ci si pone dopo aver visto ‘Non essere cattivo’ di Claudio Caligari è perché non sia in concorso. Abbiamo provato a chiederlo a Valerio Mastrandrea che è uno dei produttori e lui ha glissato (“ma perché mi fate tutti questa domanda, non sta a me rispondere”).
Un peccato, perché è finora il miglior film italiano proiettato quest’anno al Lido, purtroppo opera ultima di un regista scomparso nel maggio scorso che il sistema cinematografico aveva inspiegabilmente condannato all’oblio: un esordio folgorante, ‘Amore tossico’ presentato qui a Venezia nel 1983, quindici anni dopo ‘L’odore della notte’, un’altra ottima pellicola e poi più niente. C’è voluta proprio la testardaggine di Mastrandrea, che al regista era molto legato, per portare a termine questo progetto, e ne è valsa davvero la pena.
La storia è quella di due giovani, nella Ostia del 1995, tra futuro e malavita. Se il pensiero corre inevitabile ai ‘Ragazzi di vita’ di pasoliniana memoria c’è da dire che il merito del film sta soprattutto nel non essere un semplice spaccato fenomenologico del nuovo mondo tossico, realtà che Caligari aveva approfondito nel suo film d’esordio, ma più ambiziosamente proprio la fotografia dell’esito finale del mondo pasoliniano. Perché oggi Accattone va in discoteca, consuma e spaccia cocaina e pastiglie e se poi le cose volgono fortunosamente in positivo al massimo può venirne fuori un finale dal sapore agrodolce e niente più. Un film potente ed emozionante, arricchito dalle ottime interpretazioni di Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che già da domani si può vedere in sala.
Il rammarico per la non-presenza in concorso di ‘Non essere cattivo’ è aumentato dall’inutilità di ‘The endless river’ del sudafricano Oliver Hermaus, questo sì in corsa per il Leone d’oro che la stampa ha accolto tra fischi ed insulti. Neanche il caso di parlarne.
 11° C
11° C LIVE
LIVE










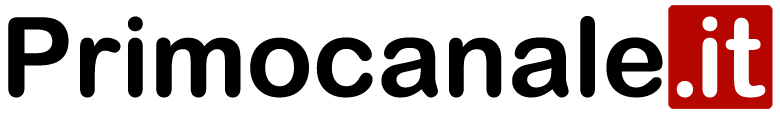
IL COMMENTO
Giorgia Fabiocchi Venerdì 19 Aprile 2024 Michele Varì Giovedì 18 Aprile 2024
leggi tutti i commentiPolitica e cittadinanza, anche il voto vuole la sua parte
Morandi, lo choc della mamma pronta a sacrificarsi e il sondaggio